Categoria: Internazionale
Comunicato Stampa FPLP
Il Fronte Popolare: Consideriamo l’occupazione pienamente responsabile della vita del compagno Segretario Generale Ahmad Sa’adat – L’attacco ai leader del movimento dei prigionieri è un’escalation pericolosa.
Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) ritiene l’occupazione sionista, il suo primo ministro fascista e criminale di guerra Benjamin Netanyahu, e il suo ministro della sicurezza fascista e razzista Itamar Ben Gvir pienamente e direttamente responsabili della vita del Segretario Generale del Fronte, il compagno Ahmad Sa’adat, che si trova in condizioni sanitarie e umanitarie estremamente critiche nelle celle di isolamento del carcere di Megiddo, specialmente dopo essere stato aggredito brutalmente durante il suo recente trasferimento.
Ciò a cui è sottoposto il compagno Sa’adat è un crimine deliberato da parte dell’occupazione sionista, che rientra in un’escalation sistematica e pericolosa volta a eliminare lentamente, fisicamente e psicologicamente, i leader del movimento dei prigionieri, attraverso la negligenza medica, la tortura, i maltrattamenti, l’isolamento e la fame sistematica.
Il Fronte avverte che questa escalation ha colpito anche il compagno Ahed Abu Ghoulmeh, membro dell’Ufficio Politico del FPLP e responsabile del ramo carcerario, trasferito recentemente al carcere di Gilboa in condizioni dure, insieme a diversi simboli del movimento dei prigionieri appartenenti ad Hamas, Jihad Islamica e lo stesso Fronte Popolare, tra cui i leader Hassan Salameh, Abdullah Barghouthi e Ibrahim Hamed, sottoposti a una campagna di maltrattamenti e torture senza precedenti.
Il FPLP rinnova il suo impegno, insieme alle forze della resistenza, a sacrificare tutto il necessario per la liberazione di tutti i prigionieri, in prima linea il Segretario Generale Ahmad Sa’adat e i suoi compagni leader, e porre fine alla loro sofferenza continua nelle carceri dell’occupazione.
Il Fronte invita il nostro popolo palestinese, le forze vive della patria e della diaspora, tutti i popoli liberi del mondo e le organizzazioni internazionali per i diritti umani e umanitari ad agire urgentemente e con efficacia, partecipando alla più ampia campagna di solidarietà con i prigionieri, per fare pressione sull’occupazione affinché fermi questi gravi crimini, salvi la vita dei detenuti e smascheri queste pratiche di fronte all’opinione pubblica mondiale.
Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina
Ufficio Centrale dei Media
NELL’OBLIO E NEL SILENZIO DEI MEDIA con la Resistenza e il popolo palestinese sino alla vittoria

Più di 100 anni dall’inizio dell’occupazione coloniale della Palestina che nel ’47-48 del secolo scorso ha causato l’uccisione di migliaia di abitanti, la distruzione di 800 villaggi e città e l’espulsione di centinaia di migliaia di palestinesi (la 1^ Nakba). Guerre, stragi, repressioni, omicidi, le proprie case i propri terreni, occupati, distrutti da coloni sionisti, questo è quanto rappresenta lo stato nazisionista di israele, questo è quanto rimane nella coscienza del Popolo Palestinese, questo è quanto scivolato nell’oblio nel pensiero e nella propaganda occidentale e imperialista.
Il genocidio del Popolo Palestinese, il tentativo della sua deportazione, per liberare nuovi territori da asservire all’interesse imperialista e sionista continua sotto un silenzio assurdo e criminale del mondo dell’informazione italiana e occidentale. Governo e opposizione parlamentare, complici con quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania, continuano a sostenere e a finanziare israele e il suo esercito.
I paesi arabi, EAU, Qatar, Arabia saudita, Egitto, ridisegnati dall’occidente dopo le false primavere arabe che hanno lasciato indenni tutte le monarchie petrolifere e distrutto tutti gli stati antimperialisti (Iraq, Libia e Siria) che si contrapponevano agli interessi imperialisti degli USA e dei suoi alleati, con le loro borghesie ormai indottrinate dal sionismo, non vogliono inimicarsi l’entità colonialista e l’occidente imperiale. I BRICS, rappresentanti il nuovo ordine internazionale con in testa Russia e Cina, non vogliono interferire negli interessi di israele, il sionismo può sempre essere utile per le loro mire imperialiste.
Tutto il silenzio costruito intorno alla Resistenza Palestinese, tutte le falsità diffuse per far scendere nell’oblio decine di anni di colonizzazione e orrori non sono bastate al potere statale imperialista per uniformare le menti di milioni di cittadini, lavoratori, proletari, e per spezzare la solidarietà al Popolo Palestinese.
Il 12 aprile si è svolta a Milano la più grande manifestazione a favore del Popolo Palestinese degli ultimi anni, 50.000 persone hanno partecipato e sfilato contro il genocidio, la deportazione, le spese militari, le politiche di guerra e di appoggio ad israele del governo Meloni e la repressione, una grande partecipazione dei migranti arabi e di giovani. Una manifestazione cosciente dell’importanza della solidarietà e della partecipazione, cosciente del rischio repressivo, soprattutto dopo l’approvazione del decreto-legge 48 (ex DDL1660) sulla sicurezza finalizzato alla pacificazione sociale forzata per poter avanzare verso il riarmo e l’economia di guerra.
Come da copione, le provocazioni delle forze dell’ordine si sono ripetute: hanno attaccato un corteo pacifico con la scusa di qualche vetrina rotta, hanno spezzato il lungo corteo in due tronconi, hanno caricato e fermato compagni. Vanno denunciate le sedicenti forze democratiche (sindacati collaborazionisti, associazioni partigiane, sociali, culturali), che, con la loro immobilità contro le leggi liberticide e il loro silenzio sul genocidio del Popolo Palestinese si rendono complici di quanto sta accadendo in Italia e in Palestina.
SEMPRE A FIANCO DEL POPOLO E DELLA RESISTENZA PALESTINESE
PALESTINA LIBERA DAL FIUME AL MARE
NO AL RIARMO E ALLE GUERRE IMPERIALISTE
UNITI CONTRO LA REPRESSIONE
Unione di Lotta per il Partito comunista – ULPC
https://unionedilottaperilpartitocomunista.org – ulpc@autoproduzioni.net
Essere radicali, nel senso di andare alla radice del problema: il regime capitalista! La soluzione è la trasformazione dell’attuale formazione economico-sociale nel sistema che cancella sfruttamento e oppressione. Per questo, c’è bisogno dei comunisti organizzati in grado di trasformare le lotte di difesa, di resistenza, rivendicative, in lotta per la nuova società: il socialismo.
Unione di Lotta per il Partito Comunista propone a comunisti e comuniste, ad avanguardie nei luoghi di lavoro, a operai avanzati e studenti impegnati nella lotta di classe, un percorso/processo/progetto per costruire l’Organizzazione oggi, come base e condizione per la ricostruzione del Partito. Un lavoro complesso e difficile, per spezzare ogni logica settaria, divisiva, localistica, per combattere la frantumazione del movimento comunista nel nostro paese.
La nascita del sionismo

Alcune note per inquadrare e capire meglio quello che avviene oggi in Palestina, e perché
Solitamente si fa risalire la nascita del sionismo a Theodor Herzl (1) e al primo Congresso sionista di Basilea nel 1897 che fondò l’Organizzazione Sionista mondiale.
In realtà il termine sionismo fu coniato nel 1890 da Nathan Birnbaum nella sua rivista Selbst-Emanzipation! (Autoemancipazione!) per indicare un movimento politico che cercasse l’appoggio delle potenze mondiali per l’insediamento di colonie agricole in Palestina, tuttavia l’idea di uno Stato ebraico nasce ben prima.
A metà del 1600, Oliver Cromwell fu a capo della rivoluzione inglese che instaurò per qualche anno il Commonwealth of England, ossia la Repubblica d’Inghilterra. Facendo leva sugli ideali religiosi calvinistici e puritani, realizzerà le principali rivendicazioni economico-sociali della borghesia inglese concedendo una relativa libertà di religione, salvo ai cattolici in quanto sostenitori della monarchia; consentì informalmente agli ebrei di ritornare in Inghilterra, dopo 350 anni dalla loro cacciata per opera di Edoardo I°, ma nel contempo lanciò anche l’idea che essi dovessero avere un proprio Stato in Palestina.
A cavallo degli anni ’60 e ’70 del 1800, il Primo Ministro anglicano Benjamin Disraeli, forte sostenitore dello sviluppo coloniale britannico, propose di allearsi con le borghesie della diaspora ebraica per rafforzare la politica coloniale britannica.
Nello stesso periodo, quello in cui nascevano dalla grande industria i grandi monopoli che segneranno il passaggio del capitalismo alla sua fase imperialista, il reverendo statunitense William Eugene Blackstone, nonché imprenditore nel settore immobiliare, pubblicò nel 1878 il libro Jesus is Coming (Gesù sta arrivando), tradotto in 48 lingue e venduto nei decenni successivi in milioni di copie, in cui affermava che il ritorno degli ebrei in Palestina era la precondizione per la loro conversione al cristianesimo e per la seconda venuta di Cristo sulla terra. Nel 1891 inviò una petizione, passata alla storia come “Blackstone Memorial” (2), al presidente USA di allora, Benjamin Harrison, affinché convincesse gli Stati europei, l’Impero Ottomano e la Russia zarista a far emigrare gli ebrei russi in Palestina. La sua notevole influenza negli USA portò in seguito milioni di cristiani nordamericani a identificarsi come cristiani sionisti.
Al primo Congresso sionista del 1897, Herzl e i sionisti furono molto abili a sfruttare, da una parte, alcuni episodi di antisemitismo (3) e dall’altra i sentimenti nazionalistici dominanti in quell’epoca (4) per promuovere l’idea della necessità di creare uno Stato ebraico indipendente (5); vale la pena sottolineare che allora la Palestina non era ancora l’unica opzione territoriale prefigurata: furono, infatti, prese in forte considerazione l’Argentina, l’Uganda e successivamente, su disponibilità del governo inglese, il Kenia.
Fu proprio il reverendo Blackstone a suggerire a Herzl di focalizzarsi sulla Palestina facendo leva sui miti religiosi e richiamando i riferimenti biblici, che furono travisati in senso razzista, per coinvolgere il maggior numero possibile di ebrei europei nel progetto sionista. La maggior parte degli ebrei, infatti, era inizialmente piuttosto ostile ai sionisti: la quasi totalità dei capi delle comunità ebraiche, dei rabbini e degli ebrei praticanti considerò il sionismo come una specie di eresia in quanto la pretesa di riunire gli ebrei in Palestina prima dell’avvento del messia era considerata una sfida umana alla divinità; fino ad allora la biblica Eretz Israel, la Terra di Israele, era considerata dagli ebrei della diaspora tuttalpiù come luogo di pellegrinaggio (6).
Il razzismo fu fin dall’inizio una delle caratteristiche specifiche del sionismo che, non a caso, si appropriò del peggior antisemitismo per mistificare la concezione di ‘popolo ebraico’. Il concetto di “popolo eletto”, che nella religione ebraica ha il significato di investitura divina dell’onere e della responsabilità di tracciare, col proprio esempio, un percorso universale verso la redenzione, viene travisato nel senso di una presunta superiorità degli ebrei. Alcune citazioni. Herzl, nel suo libro Der Judenstaat (Lo Stato ebraico) del 1896: “L’ebreo, essere intelligente per natura” … “Siamo un popolo, è il nemico a renderci tale … come è sempre stato nel corso della storia”. David Ben Gurion: “Gli ebrei sono diversi dagli altri popoli per il loro destino, la loro storia, le loro tradizioni nazionali, la loro fede; il loro credo e la Bibbia sono più universali delle credenze degli altri popoli”. Menachem Begin, futuro primo ministro dello Stato sionista: “I palestinesi sono bestie che camminano su due gambe”. Rafael Eitan, che avrà il ruolo di comandante dell’esercito israeliano “L’arabo migliore è l’arabo morto”.
Tornando alla fase della nascita del sionismo, Herzl nel 1902 dichiarando esplicitamente in una lettera che il suo era un progetto coloniale, cercò l’appoggio di Cecil Rhodes, che diede il proprio nome alla Rhodesia e fu proprietario di una delle principali imprese coloniali inglesi, la British South African Company (Compagnia Britannica del Sudafrica) e della compagnia mineraria De Beers. E proprio dalla Compagnia Britannica del Sudafrica Herzl mutuò il modello operativo che avrebbe adottato l’Agenzia Ebraica (7), attraverso la quale venivano sottratte le terre alle popolazioni native. D’altra parte, Herzl già nel suo libro Lo Stato Ebraico scriveva a proposito della Palestina: “In favore dell’Europa costruiremo là una parte del vallo per difenderci dall’Asia, costituendo così un avamposto della cultura contro la barbarie”.
Durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1916 mentre firmava segretamente l’Accordo Sykes-Picot con la Francia e il consenso della Russia zarista per la spartizione del Medio Oriente (8), il governo inglese cercò di convincere la borghesia ebraica statunitense a fare pressione sull’amministrazione USA affinché intervenisse in guerra come loro alleati; a questo scopo avviò trattative con i sionisti che accettarono il protettorato britannico avendo in cambio la promessa che sarebbe stata facilitata l’emigrazione di ebrei in Palestina. Le trattative, a dimostrazione degli stretti rapporti tra il sionismo e l’imperialismo britannico e nordamericano, portarono nel 1917 alla Dichiarazione Balfour (9) nella quale il governo inglese si impegnava a favorire la costituzione di un “focolare” nazionale ebraico in Palestina. Nel 1920, con la Conferenza di San Remo, nella quale, oltre all’attuazione dell’Accordo Sykes-Picot venne inclusa anche la Dichiarazione Balfour, fu avviato il mandato di protettorato britannico sulla Palestina.
Con l’intensificarsi dell’immigrazione sionista in Palestina si acuirono le contraddizioni nazionali e sociali: i coloni sionisti, con il sostegno dell’Agenzia Ebraica, comprarono le terre migliori dai latifondisti locali, che per lo più vivevano ormai in città, cacciarono via i contadini e i braccianti palestinesi stabilendo la regola che i datori di lavoro sionisti potevano assumere esclusivamente lavoratori ebrei, al fine di escludere i palestinesi dal mercato del lavoro.
Nel 1929 iniziarono i primi scontri di una certa rilevanza tra palestinesi e coloni sionisti, nel 1936 fu proclamato il primo sciopero contro l’immigrazione sionista. Questi risposero esplicitando l’intenzione di procedere con la pulizia etnica cacciando tutti i palestinesi oltre il fiume Giordano, mentre il governo inglese, attraverso una commissione d’inchiesta, esiliava i capi palestinesi. Tutto ciò con il sostanziale avvallo di tutte le potenze imperialiste occidentali dell’epoca che avevano tutto l’interesse a lasciare sviluppare a loro immagine e somiglianza la creatura mostruosa che avevano contribuito ad innestare in un’area strategica sia dal punto di vista geografico che di risorse energetiche.
Fu la chiara smentita, se ce ne fosse bisogno, dello slogan sionista “una terra senza popolo per un popolo senza terra”, figlio dell’aspetto razzista che è insito nell’ideologia di cui si ammanta il colonialismo prima e l’imperialismo dopo. In questa narrazione ideologica, infatti, i territori occupati sono sempre “terra di nessuno” così come sono “nessuno” o tuttalpiù “da civilizzare” i popoli indigeni.
È significativo notare che in quegli stessi anni, gli anni venti e trenta del ‘900, si svilupparono in Palestina importanti mobilitazioni e scioperi nei luoghi di lavoro che videro lottare insieme, fianco a fianco, lavoratori palestinesi ed ebrei, nonostante i pesanti tentativi delle classi dirigenti sia palestinesi che sioniste di reprimerle. Le borghesie palestinesi e sioniste non esitarono a fare fronte comune davanti al pericolo, per esse mortale, che lavoratori palestinesi e lavoratori ebrei si unissero in una lotta di classe comune che avrebbe potuto mettere in discussione sia il progetto sionista che il potere delle élite palestinesi, entrambi protetti dall’imperialismo inglese e occidentale. È significativo, inoltre, che gli scioperi fossero osteggiati pure dal sindacato sionista Histadrut (10) nelle cui fila non erano ammessi i palestinesi (fino al 1959) e nemmeno gli immigrati non ebrei (fino al 2011) ma era l’unico sindacato abilitato a firmare contratti collettivi di lavoro; proprio a causa del sostegno incondizionato dato alle lotte unitarie dei lavoratori palestinesi ed ebrei, i comunisti furono espulsi dal sindacato che li denunciò come “nemici del popolo ebraico”. Un sindacato quindi molto particolare che investiva e deteneva importanti quote di proprietà di imprese sioniste, ritrovandosi a svolgere anche il ruolo di datore di lavoro: un’organizzazione lontanissima dal sindacalismo di classe e che invece si faceva Stato.
Nel 1939 il governo britannico, nel timore di inimicarsi le borghesie dei paesi arabi, pubblicò un Libro Bianco nel quale prendeva atto che era nato un ‘focolare’ nazionale ebraico, sosteneva che fosse necessario porre fine all’immigrazione ebraica e alla vendita di terreni e si doveva concedere l’amministrazione autonoma ai legittimi proprietari del paese entro i 5 anni. L’anno successivo venne promulgata la legge che vietava agli immigranti l’acquisto di terre palestinesi. La reazione sionista fu feroce: mentre l’Agenzia ebraica iniziò ad organizzare l’immigrazione illegale, i sionisti scatenarono il terrorismo attraverso l’Irgun (Organizzazione militare nazionale), tra i cui dirigenti vi fu Begin, il Lehi (Combattenti per la libertà di Israele), ossia la Banda Stern, tra i cui dirigenti vi fu Shamir), e la Haganah, la loro organizzazione paramilitare.
Intanto l’emigrazione degli ebrei in Palestina languiva, soprattutto quelli tedeschi e dell’Europa orientale, che rappresentavano gran parte delle comunità ebraiche europee, dimostravano uno scarso interesse verso il sionismo. Questo spiega, insieme alla comune ideologia basata sulla presunta superiorità razziale (dei tedeschi per i nazisti, degli ebrei per i sionisti), il motivo per cui i dirigenti sionisti videro con interesse l’ascesa del nazismo definita “un’occasione irripetibile per costruire e prosperare” da Moshe Beilinson (11); ancora più esplicito Ben Gurion nel 1938: “Se sapessi che è possibile salvare tutti i bambini della Germania portandoli in Inghilterra, e solamente la metà di essi portandoli in Eretz Israel, sceglierei la seconda soluzione. Perché non dobbiamo pensare solamente alla vita di questi bambini, ma anche alla storia del popolo d’Israele” (12). Dall’altra parte l’interesse era ampiamente ricambiato, così scriveva nel 1935 il famigerato Reinhardt Heydrich (13), ufficiale delle SS poi capo della Gestapo: “Dobbiamo separare gli ebrei in due categorie, i sionisti e i sostenitori dell’assimilazione. I sionisti professano una concezione strettamente razziale e sono favorevoli all’emigrazione in Palestina, essi aiutano a costruire il loro proprio Stato ebraico … le nostre buone intenzioni e la nostra buona volontà ufficiale sono dalla loro parte” (14).
La collaborazione tra sionisti e nazisti si concretizzò nel 1933 e durò fino al 1941 attraverso due imprese create appositamente per favorire l’emigrazione ebraica dalla Germania in Palestina e per aggirare il blocco delle esportazioni delle merci tedesche decretato dagli inglesi: la Paltreu con sede a Berlino e la Ha’avara con sede a Tel Aviv. Attraverso di esse gli ebrei che volevano emigrare, quelli che economicamente se lo potevano permettere, versavano somme di denaro e vendevano i loro beni in Germania in cambio di merci tedesche che avrebbero ricevuto in Palestina una volta arrivati là. La collaborazione era vantaggiosa sia per i nazisti che per i sionisti: i primi riuscivano ad esportare i propri prodotti e farli arrivare perfino in Gran Bretagna attraverso i sionisti aggirando il blocco; per parte loro, i sionisti riuscivano ad attuare un’emigrazione selettiva verso la Palestina; selettiva perché ai sionisti servivano immigrati ebrei utili alla costruzione di uno Stato, ossia imprenditori, professionisti, tecnici, personale qualificato, mentre gli ebrei delle classi subalterne potevano essere cinicamente abbandonati al loro destino di sterminio.
Alla fine del 1947 l’ONU, con la risoluzione n. 181 votata a maggioranza, complice l’ondata di sdegno dell’allora recentissimo sterminio nazista degli ebrei che i sionisti sfruttarono biecamente e cinicamente (15), fu decisa la spartizione della Palestina in uno Stato sionista, uno Stato palestinese e Gerusalemme sotto tutela internazionale (16). Pochi mesi dopo i sionisti inasprirono gli attacchi terroristici in diversi villaggi con lo scopo di cacciare i Palestinesi, un esempio su tutti: Deir Yassin fu raso al suolo dalla Banda Stern e tutti i suoi 260 abitanti furono sterminati. Un giorno prima della scadenza del mandato britannico sulla Palestina, il 14 maggio 1948 i sionisti proclamarono lo Stato di Israele provocando l’intervento degli eserciti arabi di Egitto, Siria, Libano, Giordania e Iraq che ne usciranno sconfitti. Oltre 750.000 palestinesi, su invito dei dirigenti della Lega Araba ma anche atterriti dal brutale terrorismo delle spietate bande armate sioniste, furono sostanzialmente costretti a lasciare le proprie case e le loro terre. L’inviato dell’ONU, Bernadotte di Svezia, a capo della commissione che valutò necessario limitare l’ulteriore immigrazione ebraica e garantire al più presto il ritorno dei palestinesi, fu barbaramente assassinato dalla Banda Stern, in totale spregio di qualsiasi decisione della comunità internazionale.
Questa, in estrema sintesi, la storia della nascita dell’entità sionista, figlia di una ideologia nazionalista e razzista, lontana dall’ebraismo autentico e inscindibilmente legata al colonialismo e all’imperialismo occidentale.
Note
(1) Herzl, giornalista austriaco, di origine ebraica ma ateo come molti borghesi europei del suo tempo, inizialmente sostenne l’assimilazione degli ebrei alle popolazioni delle nazioni in cui vivevano, eventualmente attraverso la conversione al cristianesimo, quale soluzione per la loro piena partecipazione alla vita politica e sociale in Europa.
(2) Nella petizione si afferma: “Perché le potenze che con il trattato di Berlino, nel 1878, diedero la Bulgaria ai bulgari e la Servia (Serbia) ai Serviani (serbi) non restituiscono ora la Palestina agli ebrei? Queste province, così come la Romania, il Montenegro e la Grecia, furono strappate ai turchi (ex impero ottomano) e cedute ai loro proprietari naturali. La Palestina non appartiene di diritto agli ebrei?”; il “Blackstone Memorial” è considerato, ante litteram, la Dichiarazione Balfour statunitense.
(3) Citiamo l’affare Dreyfus, un capitano dell’esercito francese di origine ebraica ingiustamente condannato per spionaggio a favore dei tedeschi; i pogrom in Russia che non erano altro che mobilitazioni reazionarie zariste per dirottare il malcontento popolare verso gli ebrei.
(4) Sono gli anni della crescita della grande industria in Europa che spinge la borghesia ad affermare il suo ruolo di classe egemone attraverso il nazionalismo per superare la frammentazione di alcuni stati, ad es. Germania e Italia, che era un ostacolo allo sviluppo del capitalismo.
(5) Il congresso adottò il Programma di Basilea, in base al quale si dichiarava che lo scopo del sionismo era quello di creare una casa per gli ebrei, tutelata dalla legge e internazionalmente riconosciuta; i principali punti del programma prevedevano: la centralità dell’insediamento rurale e l’autonomia dei produttori ebraici rispetto alle altre comunità autoctone; la promozione del “sentimento nazionale” tra gli ebrei della diaspora; la ricerca, per via diplomatica, del consenso da parte delle potenze mediterranee ed europee; la costituzione di istituzioni in grado di organizzare gli immigrati ebrei, indirizzandoli verso l’obiettivo di attuare il futuro insediamento coloniale.
(6) Gli ebrei ultraortodossi, da non confondere con i fondamentalisti e gli integralisti, accusarono i sionisti di aver totalmente trasgredito ai tre giuramenti secondo i quali gli ebrei avrebbero promesso a dio di non usare la forza per tornare in Israele, di non ribellarsi alle nazioni che li opprimevano e di non tentare alcuna azione per accelerare la redenzione, ma di aspettare, invece, che si compisse la giustizia divina. Alcuni di questi ebrei ultraortodossi hanno poi creato il movimento Neturei Karta (Guardiani della città), che auspica la scomparsa dello stato sionista e tuttora solidarizza attivamente con i palestinesi e la loro lotta di liberazione.
(7) Così Herzl spiega il funzionamento dell’agenzia: “Cos’è oggi l’estrazione dell’oro nel Transvaal (regione del Sudafrica)? Non ci sono vagabondi avventurieri, solo geologi e ingegneri esperti sono sul luogo per controllarvi l‘industria dell’oro e per utilizzare ingegnosi macchinari per separare il minerale dalle pietre. Ben poco ora è lasciato al caso. Quindi dobbiamo studiare e prendere possesso del nuovo Paese ebraico mediante ogni moderno espediente”. La realizzazione del terzo punto del Programma di Basilea si concretizzò nella fondazione di: Jewish Colonial Trust (Banca Nazionale Ebraica) nel 1899, Keren Kayemet Leisrael (Fondo Nazionale Ebraico) nel 1900, Jewish Agency (Agenzia Ebraica) nel 2022, che furono le istituzioni che si occuparono di raccogliere i fondi per l’aqcuisto dei terreni e per la loro amministrazione. L’Agenzia Ebraica nel 1929 fu riconosciuta ufficialmente dal governo Britannico e cominciò ad affiancare l’amministrazione inglese in Palestina.
(8) L’accordo, che prendeva il nome dei rappresentanti inglese e francese, fu stipulato in previsione della sconfitta dell’Impero Ottomano e poi modificato alla fine della guerra; assegnava alla Gran Bretagna il controllo dei territori corrispondenti all’attuale Giordania, Iraq meridionale e la parte settentrionale della Palestina, alla Francia il Libano, la Siria, l’Anatolia sudorientale e l’Iraq settentrionale, alla Russia Costantinopoli e l’Armenia, il resto della Palestina sarebbe stato sotto il controllo internazionale. Fu svelato nel 1918 dal governo sovietico dopo la Rivoluzione d’Ottobre.
(9) La Dichiarazione Balfour, dal nome del ministro degli esteri Arthur James Balfour, consisteva in una lettera indirizzata a Walter Rothschild, esponente della comunità ebraica e principale rappresentante del movimento sionista in Inghilterra, recante il seguente testo: “Ministero degli Affari Esteri, Londra 2.11.1917; Caro Lord Rotschild, Sono molto lieto di inviarle da parte del governo di Sua Maestà la seguente dichiarazione di simpatia per le aspirazioni degli ebrei sionisti, che è stata sottoposta e approvata dal Gabinetto. Il Governo di Sua Maestà vede con simpatia lo stabilirsi in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico ed userà i suoi migliori uffici per facilitare il conseguimento di questo obiettivo, essendo chiaramente comprensibile che nulla sarà fatto che possa pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina o i diritti e gli statuti politici che gli ebrei godono in ogni altro paese. Le sarò grato se porterà questa dichiarazione a conoscenza della federazione sionista. Sinceramente vostro Arthur James Balfour”.
(10) L’Histadrut (Confederazione Generale dei Lavoratori in Israele) fu fondata ad Haifa nel dicembre del 1920 e rappresentò una delle principali organizzazioni dell’emigrazione sionista in Palestina; finanziata dall’Organizzazione Sionista Mondiale, e dall’Agenzia Ebraica, costituì attività produttive, cooperative agricole, costruì e gestì abitazioni, scuole e ospedali, servizi assistenziali, fondò istituti di credito. Fino alla proclamazione di Israele l’Histadrut svolse sostanzialmente un ruolo sostitutivo di uno stato in formazione, l’attività prettamente sindacale fu del tutto secondaria, rivolta comunque alla tutela esclusiva dei lavoratori ebrei e fondata sulla discriminazione istituzionalizzata di quelli non ebrei.
(11) Moshe Beilinson, nato in Russia nel 1989 dove fin da giovane aderì al movimento sionista, si trasferì in Italia alla fine della prima guerra mondiale dove assunse la presidenza del gruppo sionista italiano Avodà; antisovietico convinto, fu autore di molti libri sul sionismo, collaborò con diverse testate giornalistiche italiane dell’epoca incentrate sulla Russia e sul sionismo.
(12) Yvon Gelbner, Zionist policy and the fate of European Jewry, in Yad Vashem Studies, Gerusalemme.
(13) Heydrich, Reinhard, detto der Henker (il boia), entrato nelle SS nel 1931, fu messo a capo della Gestapo nel 1936; fu nominato, nel 1941, vice-protettore del Reich nella Boemia e nella Moravia, dove perseguitò l’opposizione e la popolazione tutta con ferocia inaudita. Fu ucciso in una operazione della Resistenza cecoslovacca e per rappresaglia fu distrutto e raso al suolo il villaggio di Lidice, vicino a Praga.
(14) H. Höhne, Order of the Death’s Head, New York, Ballantine, 1971.
(15) Per quanto i sionisti cerchino di affermare il monopolio ebraico dello sterminio nazista, la realtà è ben diversa. La natura classista e razzista del nazismo, le sue teorie sulla ‘superiorità ariana’, fece sì che le prime vittime del genocidio furono gli oppositori al regime e coloro che ‘minavano la purezza della razza’ ed erano solo un costo per la società: comunisti, socialisti, sindacalisti, antifascisti, insieme a malati di mente, disabili, portatori di malattie genetiche, omosessuali. In seguito la “soluzione finale” fu applicata, oltre che a 6 milioni di ebrei, a 500.000 zingari, 5.000 testimoni di Geova, 3,3 milioni di prigionieri sovietici.
(16) La risoluzione 181 del 29 novembre 1947 attribuisce il 56,47% del territorio a 500’000 ebrei + 325’000 palestinesi, il 43,53 % del territorio a 807’000 palestinesi + 10’000 ebrei, la tutela internazionale su Gerusalemme con circa 100’000 ebrei e 105’000 palestinesi, oltre ad altre prescrizioni. La parte assegnata ai sionisti era costituita dai terreni migliori dal punto di vista agricolo, molti dei quali erano stati sottratti illegalmente ai palestinesi. Alla data della risoluzione, i sionisti occupavano già il 75 % della Palestina.
In Siria, stesso copione già visto in altri Paesi

Jihadisti conquistano Damasco senza la difesa dell’esercito siriano e con il ritiro di hezbollah. Occupano la TV di Stato e devastano il palazzo del governo e la residenza del presidente, arrestano il primo ministro al Jalali, liberano i prigionieri, gli esuli già ritornano, le masse (dicono) sono in piazza per manifestare la propria gioia. E impongono il coprifuoco dalle 16 alle 5 mattino.
Politici e massmedia si lanciano in un attacco di Assad: dittatore, reo di atrocità, che reggeva un regime sanguinario da oltre 50 anni ecc.
Quello dei “portatori di democrazia” è un copione già visto in epoche recenti con gli interventi in Libia, Iraq, Afghanistan ma i risultati non si vedono.
I ribelli entrano persino nell’Ambasciata italiana e il ministro degli esteri italiano dichiara che non hanno fatto nulla né al personale diplomatico, né ai carabinieri di guardia, hanno solo preso 3 auto. Togliete gli alcolici da casa Tajani! Jihadisti entrano sul suolo straniero e i carabinieri che ci stanno a fare? Le vacanze come in Albania? Se fosse successo in Palestina avrebbero scatenato il finimondo contro l’aggressività dei terroristi e la violazione del suolo italiano.
Trump sostiene che gli Usa non devono farsi coinvolgere. I padroni della Nato, cioè USA (e GB) auspicano che il conflitto non porti alla recrudescenza dell’isis, formazione creata da loro stessi, e promettono di proteggere i vicini Israele, Giordania e Iraq in questo periodo di transizione.
Iraq chiude le frontiere, Iran resta in attesa prima di prendere una posizione, Il governo turco, da sempre anti Assad, esulta e lancia un attacco contro le milizie curde (filo USA) nel nord del paese.
Netanyahu afferma che la caduta di Assad aiuta nel riportare indietro gli ostaggi, che liberarsi da oppressione e tirannia crea nuove opportunità per israele e subito l’esercito sionista prende il controllo della zona demilitarizzata del Golan e impone il coprifuoco nelle 5 città dell’altopiano siriano occupato e annesso a israele, mentre i suoi aerei bombardano, da subito, una zona vicino a Damasco.
Tutta l’Europa e la UE si stanno dimostrando guerrafondaie.
Macron, che dovrebbe pensare alla crisi del suo paese, dichiara che lo stato di barbarie è caduto e rende omaggio al popolo siriano, al suo coraggio, alla sua pazienza assicurando che la Francia continuerà a impegnarsi per la sicurezza di tutti in Medio oriente. La Libia è un esempio!
Per il governo tedesco la fine di Assad è un sollievo per milioni di siriani, e chiede che il paese non cada nelle mani di altri radicali (sic).
La Russia, che in Siria ha le basi militari, è troppo impegnata in Ucraina e preferisce salvare l’amico lasciando la popolazione al destino islamista salafita.
Per l’Onu la Siria si trova ad un punto di svolta e aspetta “con cauta speranza l’apertura alla pace, riconciliazione, dignità, inclusione per tutti i siriani”.
L’8 dicembre è considerato un giorno storico per il medio oriente, forze capitaliste e imperialiste sono riuscite ad ottenere ciò che gli è fallito nel 2011: finire di distruggere un paese laico schierato con il fronte della Resistenza palestinese e contro l’imperialismo USA-NATO, e consegnarlo nelle mani di estremisti fondamentalisti, in attesa di spartirsi la zona.
Il capo dei ribelli di al-nusra, il maggiore gruppo fondamentalista della Siria che come obiettivo ha l’applicazione della sharia, Abu Mohammed al Jolani (Ahmed al Sharaa il suo vero nome) conferma che non ci sarà posto per gli infedeli. Jolani, sul quale pesa una taglia di 10 milioni di dollari, noto per i suoi rapporti con Stati Uniti e Cia, era già coinvolto nel conflitto da quando, nel 2014 era apparso col volto coperto in un’intervista giurando fedeltà ad al qaeda.
Questa ultima operazione e il conflitto ucraino sono inestricabilmente legati. Nella caduta della Siria – considerata un anello centrale nella regione – identificano la caduta di Putin. Se la uniamo alle violente proteste che si stanno verificando in Georgia e Moldavia, il progetto di accerchiamento della Russia è evidente. Situazione che rientra nella pericolosa politica dei governi NATO.
È significativo che i governi borghesi in occidente considerino gli islamici in Palestina spietati assassini terroristi e quelli in Siria dei liberatori del popolo siriano. E intanto israele, che si rafforza, porta avanti il genocidio a Gaza e continua gli attacchi contro i popoli palestinese e libanese con l’obiettivo dell’Iran.
ULPC (commissione internazionale, 8 dicembre 2024)
PALESTINA LIBERA DAL FIUME AL MARE
Testo del volantino distribuito il 30 novembre alla manifestazione di Roma
SCONFIGGERE IL SIONISMO E L’IMPERIALISMO

Continua il criminale genocidio del Popolo Palestinese da parte dell’entità sionista e dell’imperialismo yankee è cominciata l’invasione del Libano e continuano i bombardamenti sulla Siria, tutto questo con l’appoggio incondizionato dell’occidente.
Solo l’asse della Resistenza palestinese, libanese, irachena e yemenita può sconfiggere l’imperialismo occidentale e il suo avamposto sionista.
Nonostante il genocidio in corso, oltre 50.000 morti, i due obiettivi dei sionisti e dell’imperialismo statunitense: la liberazione degli “ostaggi” e la distruzione della Resistenza Palestinese, ad oggi non sono stati raggiunti. La Resistenza e tutto il Popolo Palestinese stanno dimostrando il loro valore e riescono a causare all’esercito sionista grandi perdite e a rallentare se non sconfiggere tutti i tentativi di invasione e di repressione.
In Palestina si sta consumando una resistenza non solo all’occupazione coloniale sionista dei territori di Palestina ma anche verso le mire espansionistiche dell’imperialismo occidentale, si sta concretizzando uno scontro di classe tra la popolazione proletaria oppressa e assassinata dall’occupante e la borghesia palestinese complice e asservita al padrone sionista, rappresentata politicamente dall’ANP.
I comunisti e gli antiimperialisti italiani devono essere al fianco della Lotta di Liberazione del Popolo Palestinese, la loro resistenza e la loro lotta devono essere la nostra resistenza e la nostra lotta, solo con la sconfitta del sionismo può nascere lo Stato libero di Palestina.
Il 30 novembre saremo ancora in piazza a Roma a manifestare il nostro appoggio alla Lotta di Liberazione in Palestina, il nostro sostegno alla popolazione, il nostro riconoscimento degli obiettivi che la Resistenza si è data, Palestina Libera Dal Fiume Al Mare.
Dobbiamo criticare fortemente le forze che si rifanno al movimento comunista e di classe, che anche in questa occasione, come già avvenuto per il 5 ottobre, contribuiscono alla divisione della piazza, dando supporto alla parte istituzionale dei Palestinesi in Italia per un secondo corteo lo stesso giorno nella stessa città, questo indebolisce tutta l’opposizione contro il nemico sionista e imperialista.
Crediamo invece importante, per il riconoscimento della Resistenza e per la sua vittoria sul sionismo, lavorare per avere un’unità di piazza anche con posizioni diversificate, pur nella consapevolezza che la lotta contro la borghesia palestinese non si debba fermare fino alla vittoria.
Per una Palestina libera. Per una Palestina Rossa
ULPC UNIONE DI LOTTA PER IL PARTITO COMUNISTA
http://www.unionedilotta.wordpress.it ulpc@autoproduzioni.net
Essere radicali, nel senso di andare alla radice del problema! Il problema è il regime capitalista, la soluzione è la trasformazione dell’attuale formazione economico-sociale nel sistema sociale che cancella sfruttamento e oppressione. Per questo, c’è bisogno dei comunisti organizzati in grado di trasformare le lotte di difesa, di resistenza, rivendicative, in lotta per il socialismo.
Unione di Lotta per il Partito Comunista propone a comunisti e comuniste, alle avanguardie nei luoghi di lavoro, agli operai avanzati e agli studenti impegnati nella lotta di classe, un percorso/processo/progetto per costruire l’Organizzazione oggi, come base e condizione per la ricostruzione del Partito. Un lavoro complesso e difficile, per spezzare ogni logica settaria, divisiva, localistica, per spazzare la frantumazione del movimento comunista nel nostro paese.
Per il 1° Maggio l’appello lanciato dai sindacati dei lavoratori di Gaza

Diffondiamo l’appello dalla Palestina dell’Unione Generale dei Lavoratori
Cari compagni nei sindacati dei lavoratori in Europa, con il cuore pieno di dolore e di sangue, nei campi profughi, tra le macerie e sulle rovine delle nostre officine, fabbriche e negozi completamente distrutti dall’aggressione “israeliana” con armi di fabbricazione statunitense ed europea, proibite a livello internazionale, rivolgiamo questo nuovo e urgente appello a voi.
Invece di festeggiare insieme il giorno internazionale dei lavoratori, viviamo questo giorno mentre siamo occupati a seppellire decine di coloro che cadono martiri ogni ora, in mezzo a una guerra di sterminio contro il nostro popolo, in cui ogni cosa nel territorio è devastata, dagli ospedali e strutture sanitarie, alle scuole, università, strade, infrastrutture e fabbriche. Neanche i bambini non ancora nati sono risparmiati dai bombardamenti israeliani.
Viviamo il crimine del secolo perpetrato contro di noi, e questa guerra distruttiva e le sue catastrofiche conseguenze sul campo, economiche e di vita quotidiana, ci costringono, come sindacati dei lavoratori e delle professioni a Gaza, ad assumerci grandi responsabilità nel raccogliere le macerie del nostro popolo, medicare le sue ferite e dolori, e il nostro ruolo nel trasmettere l’immagine di questa sofferenza senza precedenti e della catastrofe umanitaria e ambientale.
Noi, del nostro popolo, non abbiamo potuto e non possiamo più dissociarci da questa realtà. Abbiamo perso migliaia di lavoratori. Nonostante i nostri sforzi nell’aiutare il nostro popolo con il limitato supporto che riceviamo e nel far sentire alta la voce del nostro popolo nelle sedi internazionali, ci siamo scontrati con silenzio e indifferenza da parte dei sindacati internazionali.
A onor del vero va riconosciuto il ruolo importante di alcuni sindacati esteri che hanno guidato localmente le proteste contro la guerra di sterminio sionista su Gaza.
Cari compagni dei sindacati e delle federazioni dei lavoratori, una serie di temi emersi durante l’aggressione vanno sottolineati. In particolare:
1) La gravità del crimine e dello sterminio commesso contro il nostro popolo e la vera posizione degli Stati Uniti e dell’Europa, favorevoli all’aggressione, devono essere esposti e denunciati dai sindacati e dalle federazioni, così da affrontarli e contrastarli. È necessario continuare la protesta, diffonderla e esercitare pressioni per porre fine all’esportazione di armi statunitensi verso l’entità sionista, e per spingere i governi capitalisti ad abbandonare queste posizioni ostili al popolo palestinese.
2) Vanno denunciate le decisioni di licenziare o terminare i contratti di migliaia di dipendenti e lavoratori a Gaza da parte di alcune istituzioni locali, arabe e internazionali, legate alla guerra di sterminio o finalizzata a privare i lavoratori dei loro diritti e indennità, invece di rafforzare il sostegno a questi dipendenti e lavoratori e attuare pacchetti di supporto al posto del licenziamento. Questo argomento deve essere al centro delle vostre preoccupazioni e lotte.
3) Va denunciato l’atteggiamento remissivo dei sindacati internazionali, inclusa l’Internazionale dei Lavoratori, che si è distinta per posizioni leggere e dichiarazioni di facciata, senza azioni concrete sul campo mirate a pressare i decisori politici e a fermare la guerra di sterminio. Le attività sindacali si sono limitate alle conferenze e alle dichiarazioni, senza approfondire la questione del soccorso o influenzare l’opinione pubblica internazionale per denunciare la vera natura criminale del sionismo e le pratiche dei paesi alleati. Questo problema deve essere affrontato con l’adozione di una posizione efficace e decisa, che si imponga a livello internazionale. Tra le azioni necessarie c’è la lotta per vietare ai sindacati dei lavoratori di tutto il mondo di collaborare con l’entità sionista, considerandola complice nella guerra di sterminio.
In particolare, chiediamo ai sindacati di tutto il mondo, e specialmente a quelli attivi in Europa e negli Stati Uniti, di prendere la decisione di boicottare l’attività economica per protesta contro il loro ruolo nella guerra di sterminio. L’ impatto che i sindacati possono avere negli Stati Uniti e in Europa è significativo, e dovrebbe essere tradotto in un forte supporto sul fronte umanitario per centinaia di migliaia di famiglie di lavoratori, che hanno perso le loro case o le loro fonti di sostentamento, contribuendo a progetti e fondi di assistenza per i lavoratori e assicurando loro sicurezza finanziaria temporanea, in coordinamento con i sindacati palestinesi e l’Internazionale dei Lavoratori, per alleviare la sofferenza di centinaia di migliaia di nostri cittadini.
Cari compagni, vi esortiamo ad essere la nostra voce, la nostra arma e le nostre voci in tutte le capitali del mondo. Ciò che il nostro popolo e i lavoratori, in particolare, subiscono è la peggiore catastrofe conosciuta dall’umanità nel XXI secolo. Questo vi addossa la responsabilità di far sentire la nostra voce e la voce dei nostri operai affamati a tutti, non solo ai vostri popoli e governi, ma al mondo intero. C’è una nazione sotto il fuoco di ogni tipo di munizioni, ma è determinata a vivere e a resistere, e a ricostruire la desolazione che si è creata con la sua pelle, il suo sangue e i suoi sacrifici.
Grazie per i vostri sforzi e buona Festa del Lavoro. Sicuramente, porteremo il vessillo della vittoria nonostante il massacro e la distruzione.
Dai vostri compagni, i sindacati dei lavoratori e delle professioni nella Striscia di Gaza
Bashir Al-Sisi, Membro della Segreteria Generale dell’Unione Generale dei Lavoratori Palestinesi – Gaza
Appello dei lavoratori palestinesi per la giornata della terra
Un Appello dai sindacati dei lavoratori palestinesi

Lottando per la nostra terra. Lottando per la nostra libertà
Il 7 marzo, l’esercito israeliano ha bombardato la sede centrale della Federazione Generale dei Sindacati Palestinesi (PGFTU) nella Città di Gaza. La sede della PGFTU forniva servizi cruciali, tra cui un asilo per 380 bambini e un panificio che serviva molte famiglie. Questa è stata la terza volta che la sede generale della PGFTU ha subito tale distruzione, con precedenti attacchi durante il bombardamento israeliano di Gaza nel 2014.
Oltre all’edificio principale, sono state anche distrutte tre sedi PGFTU nel quartiere di Al-Rimal e a Via Yarmouk. Questo attacco non solo ha colpito gli edifici – ha colpito i mezzi di sussistenza e i diritti dei lavoratori palestinesi. Tuttavia i lavoratori palestinesi restano risoluti: perseveremo nella nostra lotta per la giustizia e la dignità.
Mentre ci prepariamo a celebrare la Giornata della Terra palestinese il 30 marzo e l’anniversario della Grande Marcia del Ritorno del 2018, continuiamo a incoraggiare i sindacati e i lavoratori di tutto il mondo a stare al nostro fianco. Chiediamo a tutte le persone di coscienza di porre fine alla complicità con i crimini di Israele, iniziando con l’immediata cessazione del commercio di armi.
La Giornata della Terra e le commemorazioni della Grande Marcia del Ritorno hanno entrambe un significato profondo per il nostro popolo, in quanto ricordano la nostra lotta duratura per la giustizia e la realizzazione dei nostri diritti inalienabili. Di fronte al genocidio israeliano e ai tentativi di pulizia etnica di Gaza, è indispensabile riaffermare la centralità del diritto al ritorno per tutti i palestinesi. La maggior parte dei palestinesi, compresi quelli di Gaza, sono rifugiati il cui diritto al ritorno alle loro case originarie rimane al centro della lotta palestinese.
Mentre ci prepariamo a osservare queste commemorazioni, ci troviamo di fronte alla straziante situazione di Gaza. I bombardamenti ininterrotti e le tattiche intenzionali di affamamento di Israele rivalano la natura genocida della sua aggressività, e infliggono le ripercussioni più pesanti sui lavoratori. L’evacuazione forzata dei palestinesi dalla regione settentrionale di Gaza, insieme agli attacchi indiscriminati contro gli sfollati e le infrastrutture vitali, sono un chiaro tentativo di pulizia etnica, una continuazione della Nakba del 1948.
Workers in Palestine è un coordinamento di 30 sindacati dei lavoratori e associazioni professionali palestinesi che hanno lanciato un appello unitario per porre fine a ogni complicità e a smettere di armare “Israele”.
Prendiamo nota delle dichiarazioni e delle azioni del movimento sindacale in risposta all’appello iniziale dei sindacati palestinesi in ottobre e rendiamo omaggio a tutti coloro che si sono schierati al fianco del popolo palestinese. Questi gesti di solidarietà, sia nelle parole che nelle azioni, sono la continuazione della grande tradizione dell’internazionalismo sindacale. Tuttavia, è necessario fare di più: durante la Giornata della Terra chiediamo un’intensificazione delle azioni per porre fine al genocidio. È indispensabile minare non solo la vendita e il finanziamento di armi a Israele, ma anche il trasporto di queste armi e di altri materiali chiave utilizzati dall’esercito israeliano per imporre il suo brutale e illegale assedio.
Chiediamo ai lavoratori e ai sindacati di tutto il mondo di mobilitarsi per la Giornata della Terra 2024 tramite:
– Il rifiuto di partecipazione nella produzione e nel trasporto di armi destinata a/o provenienti da Israele
– interrompendo la logistica delle operazioni militari di Israele, possiamo impedire la sua capacità di esercitare ulteriori violenze contro il nostro popolo.
– Il confronto della complicità governativa nel perpetuare l’aggressione di Israele. Ciò include la contestazione del rilascio di licenze per il commercio di armi, e proteste presso i Ministeri della Difesa e degli Esteri.
I governi devono essere ritenuti responsabili del loro ruolo nel facilitare il genocidio di Israele.
L’intensificazione di tutte le azioni sindacali efficaci – approvazione di mozioni, agitazione nei luoghi di lavoro, organizzazione di sessioni di educazione e creazioni di network.
Nonostante l’orrore del genocidio perpetrato da Israele e dei suoi crimini quotidiani contro i palestinesi, non possiamo disperarci o deviare la nostra attenzione. Al contrario, per celebrare questa giornata storica per il popolo palestinese nella nostra lotta di liberazione, dobbiamo rinnovare il nostro impegno a rimanere uniti come lavoratori contro l’ingiustizia.
Workers in Palestine ha redatto numerose risorse per sostenere la mobilitazione sindacale, tra cui:
Una scheda guida per i sindacalisti sulla costruzione della solidarietà con la Palestina; Una guida per attivisti su Lezioni su organizzazione con i sindacati per costruire azioni di solidarietà; Interrompendo Zim: una guida per la ricerca e la pianificazione di un’azione strategica; Un documento informativo su Chi arma Israele? e Chi fornisce a Israele nuove armi per sostenere il bombardamento di Gaza?
Contattateci per comunicare le notizie del vostro sindacato e per il coordinamento delle vostre azioni: workersinpalestine@proton.me
20 marzo 2024

IL CONFLITTO NEL NAGORNO-KARABAKH

Il conflitto nel Nagorno-Karabakh sebbene si configuri come una guerra regionale tra Armenia e Azerbaijan in realtà costituisce una tappa importante per i progetti geopolitici antagonistici di grandi potenze quali Turchia, Russia, Iran e meno esplicitamente USA, UE e Nato, in particolare per la creazione di zone di influenza nel continente euroasiatico. Negli ultimi venti anni le dinamiche di potere della regione sono state rimesse in discussione dal mutamento degli equilibri politici e militari seguiti al crollo dell’URSS e più recentemente nella nuova fase di corsa alle risorse energetiche: il Caucaso rappresenta infatti una regione vitale per la sicurezza energetica europea che aggira i rifornimenti russi. È, inoltre, per gli USA uno snodo logistico fondamentale di accesso all’Asia centrale, utile per la funzione di triplo contenimento della Russia, attraverso il suo accerchiamento dai Paesi Baltici fino appunto al Caucaso, Iran e Turchia al fine di interrompere l’asse euro-asiatico e il progetto della nuova via della seta.
Si è dunque aperta una partita nel Caucaso che va ben al di là del conflitto in esame e sarà fondamentale da un punto di vista strategico per i futuri equilibri.
INQUADRAMENTO STORICO
Il conflitto in Nagorno Karabakh rappresenta una delle questioni insolute successive alla fine dell’URSS dove sia gli Armeni che gli Azeri si contrappongono con ragioni diverse: i primi hanno dalla loro parte la ragione storica poiché il Nagorno-Karabakh è stato nel passato la sede della nobiltà armena tant’è che ospita numerosi monumenti armeni antichi, gli
altri si avvalgono della legittimità giuridica di estendere la loro sovranità statale alla regione, in base alla decisione presa dall’autorità sovietica nel 1921 di includere il Karabakh all’interno della Repubblica socialista sovietica azera.
Per una corretta analisi interpretativa del conflitto è doveroso accennare al contesto storico la cui ricostruzione, in particolare per la parte più antica, non è semplice né lineare per la carenza di documenti lasciando a diverse interpretazioni. Alcuni storici sovietici addirittura affermarono che era un luogo “dal passato imprevedibile” o “dal passato che eclissa il presente.” Di fatto in Armenia e in Azerbaijan si sono sviluppate visioni storiche contrapposte da cui si sono generati i rispettivi nazionalismi, l’uno in risposta all’altro, definiti “nazionalismi allo specchio”, dando origine ad un dibattito iniziato già dal 1950 che ha, però, preso forma negli anni 80 traducendosi in una guerra culturale per dimostrare il rispettivo dominio indiscusso e ininterrotto nella regione contro i “nuovi arrivati”.
Non è pertanto da sottovalutare come la disputa e l’estremismo delle visioni storiche abbiano avuto un peso rilevante sul conflitto, parimenti alle rispettive rivendicazioni giuridiche di autodeterminazione da parte degli Armeni e di integrità territoriale da parte degli Azeri.
La regione del Nagorno-Karabakh è erede dell’Albania caucasica i cui confini territoriali comprendevano gran parte dell’attuale Azerbaigian, la parte meridionale del Daghestan e quella più orientale della Georgia. Tuttavia, dopo il X secolo, si perse qualsiasi traccia riguardo a quegli Albani del Caucaso che sfuggirono al processo di islamizzazione e nel IV secolo si convertirono al Cristianesimo. Gli unici dati certi che possediamo in merito al Karabakh sono il fatto che a metà del XVIII secolo venne qui istituito un khanato turco e che all’inizio del XIX, la regione entrò a fare parte della Russia imperiale come provincia a cui venne dato il nome di Nagorno-Karabakh che etimologicamente svelava già la presenza dei tre poteri dominanti nel territorio; infatti nagorno significa montuoso in lingua russa; kara nero in turco, bağ significa giardino in persiano e vite in turco.
La Russia fu costretta infatti a combattere con Persiani, Ottomani ed altri popoli locali ma riuscì comunque a prevalere vincendo l’ultima guerra russo-persiana nel 1828 e annettendo i khanati di Erevan e Nakhichevan. Nel 1829, con la fine della guerra tra Russia e impero ottomano, tutta la Transcaucasica, incluso l’odierno Azerbaigian, venne definitivamente conquistata dall’impero zarista e tale evento fu di estrema importanza per le sorti dei popoli cristiani all’interno della regione, che poterono sottrarsi dal contesto politico e culturale islamico. É interessante notare che la Russia annesse solo una parte del territorio popolato dagli Azeri, mentre un’altra zona a essa meridionale rimase all’interno della Persia: ancora oggi, gli Azeri sono la seconda minoranza etnica nella Repubblica Islamica dell’Iran.
Gli Armeni furono complessivamente soddisfatti di entrare a far parte dell’impero zarista, superando momentaneamente le mire di indipendenza, sia per il fatto che nel 1828 venne creata la regione armena (se pure abolita poi nel 1840) sia perché nel 1836 venne regolamentato positivamente il legame tra l’autorità ecclesiastica ed armena, e l’élite armena (composta da una nobiltà non molto numerosa e da una più consistente borghesia) riuscì ben presto ad inserirsi negli ambienti imperiali russi e ad ottenere un’influenza notevole. È opportuno sottolineare che essendo il ceto sociale l’aspetto prevalente rispetto all’etnia e alla confessione religiosa nel sistema imperiale zarista anche le popolazioni musulmane erano riconosciute come “partner di pari dignità benché infedeli – ovviamente la loro élite – essendo politicamente sconveniente inimicarsi i popoli musulmani.
Si evince dunque che i rapporti tra la popolazione armena e azera hanno radici storiche profonde prosperate in un’area geografica ampia e molto complessa da un punto di vista dello sviluppo etnico-politico-culturale. Le radici del conflitto non sono tuttavia antiche; la forma e il contenuto della disputa armeno-azera risalgono a poco più di cento anni prima del suo inizio. Il Nagorno-Karabakh venne conteso nel 1905 e successivamente nel 1918-1920 e venne concesso all’Azerbaigian nel 1921 e suoi confini tracciati nel 1923. È plausibile affermare, quindi, che l’origine del conflitto è da ricercarsi nel Novecento, nel periodo in cui l’impero ottomano e quello russo erano ormai nella loro fase di declino e sia gli Armeni che gli Azeri scoprirono l’idea dell’autodeterminazione nazionale. Gli Armeni iniziarono a ispirarsi ai movimenti di indipendenza dei Balcani e dell’Europa orientale, e nel 1890 venne fondato il primo partito nazionalista armeno, la Federazione Rivoluzionaria Armena, meglio nota come Dashnaktsutyun o Dashnak. Allo stesso tempo gli Azeri scoprivano la loro fratellanza con i Turchi e con essi crearono stretti legami. Gli eventi catastrofici del 1915 trasformarono e accelerarono il processo: il collasso dell’impero ottomano e lo spostamento in massa della popolazione armena dalla Turchia trasformò l’Armenia russa in un territorio caotico e pieno di rifugiati. Poi, nel 1917, l’impero russo crollò e le principali nazionalità del Caucaso ottennero l’indipendenza, la quale se fu vantaggiosa per la Georgia lo fu meno per l’Armenia e l’Azerbaijan, in quanto queste neonate formazioni statali non possedevano il pieno controllo del loro territorio. Il 28 maggio 1918 sia l’Azerbaijan che l’Armenia dichiararono l’indipendenza e i due regimi nazionalisti che si installarono nei due stati nuovi Stati, iniziarono a discutere riguardo a quali fossero i confini tra le due nazioni. La svolta della Prima Guerra Mondiale e la sconfitta dell’Impero Ottomano in ottobre provocarono l’inizio di una sorta di guerra pan caucasica. Le tre Repubbliche transcaucasiche combatterono tra di loro per ottenere il
controllo dei territori di Zangezur, Nakhichevan e del Karabakh. Il Nakhichevan, andò agli Azeri, sostenuti dai Turchi, lo Zangezur, agli Armeni e per quanto riguarda il Karabakh la situazione si presentò più complessa a causa dell’intervento degli inglesi la cui politica nel sud del Caucaso non era a sostegno delle popolazioni locali ma di contrasto al rafforzamento dei Bolscevichi e delle forze socialiste. Quindi nell’agosto del 1919 l’Azerbaijan con il supporto della Gran Bretagna, firmò il trattato di incorporazione del Nagorno-Karabakh nella neonata Repubblica Democratica, ma i due popoli si contesero i territori alternandovi il loro predominio fino al luglio 1920 quando l’Armata Rossa riuscì a conquistare la regione del Karabakh.
La questione riguardante il futuro della regione venne affrontata a vari livelli
burocratici, ma non fu possibile raggiungere una soluzione che soddisfacesse le parti, per divergenze all’interno del Partito Bolscevico. Alla fine lo status del Karabakh, venne decisa da sei membri del “Kavburo”, il comitato del Caucaso, sotto il comando di Stalin e la scelta sembrò favorire l’Azerbaijan; il “Trattato di Fratellanza e di Amicizia” tra l’Unione Sovietica e la Turchia repubblicana includeva una disposizione secondo cui sia Nakhichevan che il Karabakh sarebbero stati trasferiti sotto il controllo della Repubblica Socialista Sovietica azera. Stalin infatti vedeva un potenziale alleato nel leader turco Kemal Atatürk, il quale era ostile a ogni concessione territoriale favorevole all’Armenia sovietica, visto che se quest’ultima fosse diventata potente avrebbe forse avanzato delle pretese territoriali verso la Turchia, avendone in precedenza inglobato la parte occidentale. Nel luglio del 1921 il Karabakh fu inserito nei confini della Repubblica Socialista Sovietica dell’Azerbaijan e il 7 luglio 1923, fu deliberata la formazione della regione autonoma del Karabakh, la quale includeva zone ampiamente popolate da Armeni. Nell’agosto del 1923, il villaggio armeno di Khankendi, rinominato
Stepanakert, divenne la capitale della regione autonoma, la quale venne ufficialmente proclamata nel novembre del 1924. Interessante è il fatto che il corridoio di Lachin, l’unico punto che univa il Karabakh all’Armenia, venne anch’esso annesso all’Azerbaijan, separando così definitivamente il popolo armeno presente nei due territori. A favorire inoltre la divisione dell’etnia armena in due entità territoriali fu la politica di Stalin tendente a separare le popolazioni caucasiche per prevenire future ribellioni.
Molti dibattiti sono nati in conseguenza alla decisione presa nel 1921, i cui fattori principali sono da un lato lo stretto legame economico tra Azerbaigian e Karabakh e dall’altro il fatto che questo territorio sia stato storicamente armeno e composto in maggioranza da una popolazione etnicamente armena. Di fatto queste nuove regioni erano state create per essere territori vitali dal punto di vista economico; diversi popoli, senza alcun tipo di legame etnico, venivano riuniti nella stessa formazione territoriale poiché si pensava che in tal modo avrebbero lavorato insieme per costruire una nuova economia sovietica, permettendo così anche ai popoli più arretrati di evolversi.
Le nuove disposizioni territoriali create da Lenin avevano la particolarità di mantenere uno stretto legame tra la terra e la nazionalità, permettendo quindi la conservazione del nazionalismo, anche se in modo latente, nel nuovo sistema. L’Unione Sovietica venne creata come una federazione di repubbliche, fondate in base alla loro nazionalità e alla loro composizione etnica. Ogni repubblica aveva al suo interno elementi di sovranità,
incluso il diritto formale a separarsi. Gli Armeni tuttavia erano rimasti molto delusi dalla decisione di annettere il Nagorno-Karabakh all’Azerbaigian, soprattutto perché la regione le era stata promessa nei primi anni dell’Unione Sovietica e di conseguenza quando l’Armenia entrò a far parte della compagine territoriale sovietica il pensiero persistente dell’élite armena andava al Karabakh e il principale obiettivo divenne quello di persuadere Mosca a concedere l’unificazione dei due territori. La decisione sovietica venne considerata arbitraria e non era compreso il motivo per cui il Nakhichevan avesse ricevuto lo status di Repubblica autonoma, mentre il Nagorno Karabakh era divenuta una Regione autonoma invece di proclamare il Nakhichevan come Repubblica autonoma dell’Azerbaigian e il Nagorno-Karabakh come Repubblica autonoma dentro l’Armenia.
Contro le proteste armene, gli Azeri affermavano che all’interno dell’Unione Sovietica erano presenti molte minoranze che non possedevano uno status autonomo, come ad esempio la regione di Derbent in Daghestan, maggiormente popolata da Azeri. Il Nagorno-Karabakh e Nakhichevan sono da considerarsi delle eccezioni nel sistema federativo sovietico, in quanto non vi fu nessun altro caso di regione o di repubblica autonoma in cui il nome dello stato e della regione coincideva con la nazionalità titolare o con lo stato di appartenenza come nel caso del Nakhichevan. Allo stesso tempo non esisteva dentro l’URSS nessun gruppo nazionale dotato sia di una
Repubblica (l’Armenia) che di una Regione Autonoma (il Karabakh) inserita all’interno di un’altra repubblica (l’Azerbaijan) come nel caso del Nagorno-Karabakh In generale, veniva concesso lo status autonomo solo ai gruppi indigeni senza una nazione madre in un altro territorio; l’unico esempio di nazione con due entità politiche furono gli Ossezi, dotati di
di una Repubblica Autonoma in Russia (Ossezia del Nord) e una in Georgia (Ossezia del Sud). Alle minoranze che vivevano fuori dai confini della loro repubblica nazionale, non veniva normalmente concesso lo status autonomo poiché la sistematica realizzazione di tale concessione sarebbe stata impossibile nella pratica vista la lunga lista delle minoranze che vivevano nell’altro lato dei confini nazionali, vedi i Tajiki in Uzbekistan, gli Uzbeki in Tajikistan, i Russi in Ucraina e in Kazakistan e molti altri.
L’egemonia sovietica congelò le tensioni territoriali ma in seno alla società armena continuava a covare un sentimento di insoddisfazione per l’assegnazione dei territori tant’è che dagli anni ’20 del ‘900 gli armeni del Karabakh e delle regioni circostanti iniziarono a formare delle organizzazioni clandestine per l’unificazione dell’area con l’Armenia ed ogni volta che si verificava un cambiamento politico in URSS come negli anni 1945-1965-1977 inviavano petizioni a Mosca chiedendo l’annessione della regione, che venivano regolarmente ignorate. Alla fine degli anni Ottanta con la perestrojka emersero di nuovo le istanze di annessione e dal 1987 ci fu una importante mobilitazione di massa per chiedere a Mosca l’unione del Nagorno Karabakh all’Armenia. Seguirono anni di tensione fino al crollo dell’URSS nel 1991 e con l’uscita dell’Azerbaigian dall’URSS nel 1991, gli armeni approfittando della legislazione sovietica dell’epoca (legge del 3 Aprile 1990 sulle norme riguardanti la secessione di una repubblica dell’URSS che consentiva alle regioni autonome di distaccarsi da una repubblica qualora questa avesse lasciato l’URSS) per stabilire la propria indipendenza. Il 2 settembre 1991 il soviet del NK decretò la nascita del nuovo stato confermata il 10 dicembre da un referendum e successive elezioni politiche il 26 dicembre. Il 6 gennaio 1992 veniva proclamata la repubblica indipendente del Nagorno-Karabakh, in armeno Artsakh (Montuoso).
LA STORIA DEL CONFLITTO DAGLI ANNI ’90 AD OGGI
Il 30 gennaio 1992 scoppiò la prima guerra combattuta in una condizione economica precaria che costò 30 mila morti e costrinse centinaia di migliaia di persone azere ad abbandonare le proprie case l’Azerbaijan attaccò militarmente il neo-Stato ma furono sconfitti dagli Armeni che seppero gestire bene il conflitto usando tattiche militari di terra superiori grazie alla loro buona conoscenza del territorio. Nel maggio del 1994 venne firmato l’accordo di Biskek che impose il cessate il fuoco e l’abbandono della regione. L’Armenia vinse ottenendo il controllo di una serie di territori del Nagorno ed altri intorno che gli permisero di unire l’enclave al proprio territorio. Seguirono trent’anni di quello che veniva impropriamente definito dai media “conflitto congelato” in quanto la situazione sulla linea di contatto tra forze armene e azere era tutt’altro che congelata; periodicamente infatti si sparava e morivano giovani soldati. Il Nagorno Karabakh formalmente era uno Stato indipendente ma non riconosciuto da nessun paese membro dell’ONU neanche dalla stessa Armenia che ne garantiva la difesa e il sostentamento economico. Solo in tal modo la via dei negoziati poteva restare aperta. Il gruppo OSCE di Minsk (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) era il meccanismo internazionale preposto a risolvere il conflitto ma non riuscì a superare lo stallo. Le parti concordarono a Madrid alcuni principi: il ritiro dell’esercito armeno dai distretti occupati limitrofi al Nagorno, il ritorno degli sfollati e lo svolgimento di un nuovo referendum per definire lo status futuro della regione a cui prendesse parte la minoranza azera, ma in realtà poco si mosse.
Da parte armena la vittoria nel primo conflitto del Nagorno-Karabakh rappresentava una sorta di riscatto collettivo per la perdita di quella che viene definita “Armenia occidentale”, ovvero la parte orientale dell’Anatolia dove viveva una consistente popolazione armena caduta vittima del genocidio del 1915. Da parte azera, il trauma della sconfitta assunse connotazioni altrettanto forti. La questione del Nagorno-Karabakh è così diventata uno dei miti fondanti del nazionalismo in entrambi i paesi.
La guerra del 2020. Baku, grazie alle entrate derivanti dalle sue risorse energetiche, negli ultimi due decenni ha costruito un esercito dotato delle armi più moderne. Col passare del tempo, visto lo stallo dei negoziati, le autorità del Paese si sono risolte a risolvere la questione del Nagorno-Karabakh con la forza.
Nell’aprile 2016, ci fu una prima escalation, nota come “guerra dei quattro giorni”. Si sarebbe poi capito che erano solo le prove generali. Il 27 settembre 2020, l’Azerbaigian lanciò un’offensiva che proseguì fino al 9 novembre. Nei 44 giorni di guerra, l’esercito azero ebbe la meglio sulle forze armene. Riuscì a riconquistare diversi distretti, tra i quali la città Shusha/Shushi,un luogo di particolare importanza strategica e simbolica per entrambi i contendenti sulle alture che dominano sulla capitale della regione Stepanakert.
il 9 novembre 2020, dopo la caduta della città, le parti, con la mediazione russa, firmarono un accordo di cessate il fuoco, sostanzialmente una resa armena. Per effetto del conflitto dei 44 giorni morirono più di 7 mila persone da entrambe le parti, decine di migliaia di civili armeni rimasero sfollati e cambiarono gli equilibri di forza nella regione.
In base ai nove punti dell’“Accordo di cessate il fuoco” l’Armenia si ritirò da una serie di aree limitrofe e da parte della regione del Nagorno-Karabakh così come definita in epoca sovietica. La popolazione armena di questi territori abbandonò le proprie abitazioni, in molti casi incendiandole per non lasciarle agli azeri. L’accordo però lasciava diversi punti irrisolti, tutti nodi che sarebbero venuti al pettine nel corso dei tre anni che ci portano al 19 settembre 2023. La posizione di forza acquistata nel 2020 e gli sviluppi internazionali non facevano altro che spingere Baku a far pressione sull’Armenia per risolvere la questione una volta per tutte.
In primo luogo, il documento non menzionava lo status futuro del Nagorno-Karabakh; in secondo luogo, la Russia diventava un attore fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione armena del Nagorno-Karabakh. L’accordo infatti prevedeva il dislocamento di una forza di peacekeeping russa nel territorio della regione e sul corridoio di Lachin, l’unico collegamento tra Nagorno-Karabakh e Armenia. Il Cremlino era impegnato nella difesa del territorio dell’Armenia (ma non del Nagorno-Karabakh non essendo la regione giuridicamente parte del territorio armeno) tramite l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva.
Con il ritiro delle forze armene dalle regioni limitrofe al Nagorno-Karabakh, emergeva anche la necessità di demarcare la nuova frontiera tra Armenia e Azerbaigian, ma i problemi non mancavano visto che in epoca sovietica non esistevano confini chiari. Non a caso già nei primi mesi del 2021 tra i due Paesi ci furono una serie di schermaglie.
La mediazione di Mosca riuscì a calmare le acque nell’anno che seguì la guerra del 2020, ma l’invasione russa dell’Ucraina ha fatto sentire la sua influenza sul Caucaso meridionale minando le sue capacità di mediazione. Inoltre, le sanzioni contro la Russia facevano e fanno dell’Azerbaigian un Paese fondamentale sia come transito per le esportazioni energetiche russe che come fonte di materie prime per gli stati europei. Questa dipendenza ha reso Baku impermeabile alle influenze esterne.
In questo modo si spiegano le tempistiche dell’offensiva di Baku del settembre 2022. Tra il 12 e il 14 di quel mese, l’esercito di Baku attaccò il confine internazionale tra Armenia e Azerbaigian occupando alcune zone strategiche in territorio armeno. Nell’escalation persero la vita centinaia di soldati e circa 7.600 civili armeni rimasero sfollati.
Nei mesi successivi, l’Azerbaijan concentrò invece i suoi sforzi sul Nagorno-Karabakh. Dall’inizio di dicembre 2022 Baku ha infatti bloccato il passaggio di mezzi e persone lungo il corridoio di Lachin che si era impegnata a tenere aperto nel trattato di pace del 2020.
Il blocco del corridoio di Lachin, l’unico collegamento tra il Nagorno-Karabakh e l’Armenia, ha reso progressivamente la vita nella regione più ardua. Col passare dei mesi le forniture alimentari e di medicinali sono andate diminuendo e, per lunghi periodi, mancavano gas ed elettricità. Tale situazione ha complicato le relazioni tra Russia e Armenia e, vista la già menzionata importanza del ruolo di Mosca, questo può spiegare le dinamiche che hanno portato alla fine dell’indipendenza del Nagorno-Karabakh. Il governo armeno, infatti, esprimendo malcontento per l’inazione dei peacekeeper russi di fronte al blocco del corridoio di Lachin e per il mancato intervento russo durante l’escalation del settembre 2022, ha iniziato a guardare altrove adducendo ciò per rompere la sua dipendenza dalla Russia.
Dopo tre anni la situazione nel Caucaso è ritornata ad infiammarsi e il 19 settembre 2023 l’Azerbaijan ha attaccato il Nagorno-Karabakh colpendo Stepanaker con un massiccio bombardamento di droni ed MLRS israeliani, lanci di missili in diverse direzioni distruggendo posizioni delle forze armate armene e infrastrutture militari.
Il presidente azero Aliyev aveva dichiarato che l’operazione militare sarebbe terminata solo quando le forze armene avrebbero consegnato le armi. Di fatto è quanto è accaduto nell’Artsakh, dopo solo due giorni di guerra, con il conseguente disarmo e il ritorno in patria delle forze armene. Il 20 settembre 2023 è stata raggiunta la completa cessazione delle ostilità, con la mediazione russa e si sono aperti i negoziati per discutere la reintegrazione dei territori in base alla Costituzione e alle leggi della Repubblica dell’Azerbaijan.
Si tratta probabilmente dell’atto finale del conflitto in Nagorno-Karabakh, che ha causato la morte di oltre 200 armeni, la maggior parte combattenti – in gran parte giovani facenti parte del servizio di leva obbligatorio – ma anche numerosi civili tra cui 9 bambini. I combattimenti hanno spinto oltre 100000 persone, più dell’80% dei residenti dell’enclave di etnia armena, a fuggire tanto che l’Armenia ha definito l’esodo una forma di pulizia etnica da parte degli azeri.
Il 28 settembre Samvel Shahramanyan, leader de facto dell’autoproclamata e non riconosciuta repubblica del Nagorno-Karabakh ha firmato un decreto che prevede lo scioglimento di tutte istituzioni e organizzazioni governative a partire dal primo gennaio 2024. Conseguentemente la Repubblica dell’Artsakh cesserà di esistere a causa un’operazione militare lampo, che ha cancellato trenta anni di storia in due giorni.
Cerchiamo di approfondire meglio il conflitto nel Nagorno-Karabakh partendo dall’esame del ruolo dei diversi attori in campo.
ISRAELE
Un ruolo molto rilevante nel conflitto è stato svolto da Israele che dall’inizio del 2000 ha stretto una vera e propria alleanza con Baku vendendo agli azeri armamenti per miliardi di dollari. Dati ufficiali del Sipri di Stoccolma rilevano una crescita della spesa militare azera da 1,59 miliardi di dollari a 3,1 miliardi, con incremento del bilancio totale della Difesa del 493% tra il 2004 e il 2014, superando in percentuale la maggior parte dei paesi del mondo, in cambio della fornitura di petrolio e di una importantissima infrastruttura militare di intelligence in funzione anti-iraniana sul territorio azero. La collaborazione di Baku con i Mossad e l’intelligence militare israeliana è, stata anche convalidata da fonti dell’intelligence francese, tuttavia il ministeri degli Esteri e della difesa israeliani hanno rifiutato di commentare l’uso di armi israeliane nel Karabakh o le preoccupazioni armene sulla partnership militare con l’Azerbaigian. In realtà già dal 2011 Israele ha contribuito in fornitura di armi per il 27% dell’arsenale militare azero, arrivato a ben al 70% tra il 2016 e 2020 (in relazione al secondo conflitto vittorioso contro l’Armenia) in particolare nella fornitura di droni di intelligence e tattici: ricordiamo i famosi droni kamikaze “Harop (usati contro i palestinesi in Cisgiordania) nonché missili terra-aria Barak -8. Inoltre nel 2020 ha realizzato una mappatura digitale di tutto il Nagorno Karabakh e un ponte aereo tra lo stato ebraico e l’ Azerbaigian attraverso lo spazio turco e georgiano per la fornitura continua di munizioni e attrezzature. Non è da meno anche la stretta collaborazione tra i due paesi in campo energetico: Israele, infatti, acquista circa il 40% del suo fabbisogno di petrolio (benché attualmente disponga di gas naturale in abbondanza al largo delle coste mediterranee) dall’Azerbaigian fin dagli anni ’90: lo stesso Netanyahu nel 2017 dichiara e sottolinea l’amicizia e la cooperazione tra i due popoli di lunga durata tanto da essere stata una delle prime nazioni a riconoscere la repubblica dell’Azerbaijan.
A dimostrazione della perfetta partnership il 29 marzo 2023 l’Azerbaijan ha aperto la propria ambasciata a Tel-Aviv.
Israele che oggi sta massacrando il popolo Palestinese, lo costringe all’esodo forzato, distruggendo completamente tutti i loro territori in nome dell’eliminazione dei gruppi terroristi di Hamas, nel Caucaso è uno stretto alleato degli “altrettanto spietati musulmani” Azeri e Turchi, responsabili della pulizia etnica del Karabakh.
TURCHIA
La Turchia tradizionalmente alleata all’Azerbaigian e ostile all’Armenia – non si possono ignorare le uccisioni di massa di armeni nel 1915 dallo Stato Ottomano, mai riconosciuto da Ankara né ufficialmente a livello mondiale come genocidio – in trent’anni ha sempre offerto il suo sostegno a Baku e nell’attuale conflitto ha assunto un ruolo determinante tanto che non sarebbe del tutto errato affermare addirittura che la guerra è stata congiuntamente preparata da Azerbaigian e Turchia. Le affermazioni dei rispettivi leader sono in perfetta sintonia nel sostenere: “Il conflitto sarà risolto solo se l’Armenia abbandonerà i territori occupati del Karabakh”.
La posizione di Ankara si basa sulla retorica nazionalista che guarda al mito dell’estensione territoriale dei popoli turchi dall’Asia centrale all’Anatolia. Gli azeri sono considerati fratelli, in particolare il partito del Movimento Nazionalista di estrema destra MHP (Milliyetçi Hareket Partisi in turco) alleato del Partito della Giustizia e dello Sviluppo AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi in turco) di Erdogan, ma anche i nazionalisti turchi vicini a forze politiche di centro sinistra come il Partito Popolare Repubblicano CHP (Cumhuriyet Halk Partisi in turco). La propaganda nazionalista e il suo uso mediatico è molto importante per Erdogan al fine di consolidare i consensi interni per l’affermazione dei veri “interessi di natura economica” della Turchia nel sostenere militarmente gli azeri nel conflitto del Nagorno-Karabakh. Sono pertanto stati inviati droni di ultima generazione, il sistema missilistico tattico TRLG 230,nonché, secondo il ministro degli esteri armeno, 4000 mercenari siriani sotto il controllo turco.
Più propriamente l’intervento armato si configura come un’ulteriore possibilità per il Presidente turco non solo di consolidare il legame economico con l’Azerbaigian da cui acquista svariati miliardi di gas naturale ma soprattutto di proiettare il proprio potere nella vasta regione dal Medio Oriente all’Asia Centrale, anche con l’avvallo o una minore ostilità di diversi paesi europei, facendo leva sui loro interessi energetici. La Turchia è il garante dell’asse energetico Baku-Tbilisi-Ceyhan con il sostegno implicito di USA-NATO e UE: l’Azerbaijan oggi può contare su un mercato energetico ben consolidato anche grazie al gasdotto aperto nel 2006 che dall’Anatolia aggirando il territorio armeno, passando dalla Georgia trasporta in Turchia energia del Caspio che dovrebbe arrivare anche all’Europa Mediterranea proprio attraverso le infrastrutture del gasdotto del Caucaso Meridionale (South Caucasus Pipelin), senza utilizzare le rotte russe.
Vale la pena ricordare che il corridoio Sud del gas SGC è una rete lunga 3500 km diviso in tre tronconi: la suddetta South Caucasus Pipeline (SCP), la TransAnatolian Pipeline (TANAP) e la Trans-Adriatic Pipeline (TAP) che coinvolge ben sei paesi tra i quali oltre l’Italia, che dovrebbe diventare un punto di distribuzione per l’Ue, la Georgia, la Grecia, l’Albania, la Turchia e l’Arzerbaijan con un costo di 45 miliardi. Se l’energia del Caspio potesse arrivare direttamente in Europa molti paesi dell’Unione non prenderebbero certamente posizione a favore dell’Armenia, per non rinunciare agli interessi energetici con Baku. Quindi è ben comprensibile come per la Turchia sia fondamentale mantenere un forte legame con l’Azerbaijan e a confermare ciò è l’incontro del 25 settembre scorso tra i presidenti Aliyev ed Erdogan nel Nakhicevan per l’inaugurazione di un nuovo gasdotto collegato alla rete turca dal nodo di Igdir: il gasdotto Igdir-Nakhicevan destinato a rafforzare ulteriormente la collaborazione azero-turca nel settore energetico, contribuendo potenzialmente anche alle forniture di gas all’Europa. Il Nakhicevan rappresenta dunque un grande potenziale per lo sviluppo di rotte per energia, trasporti e logistica Est-Ovest. Questa è la vera posta in gioco della Turchia più del Nagorno-Karabakh per avere collegamento diretto con il mar Caspio e l’Asia Centrale. Il corridoio consentirebbe dunque di collegare in modo più stretto Turchia e Azerbaigian nell’ottica “due Stati una sola nazione”. Sarà dunque all’ordine del giorno dopo la disfatta armena, anche considerando che ormai il divieto di rottura dell’asse Armeno-Iran che era assicurato dalla presenza russa nel territorio è venuto meno.
IRAN
Pur ammettendo l’importanza fondamentale nel conflitto del Caucaso Meridionale del Southern Gas Corridor (SGC) quale primo serbatoio del gas per l’Europa e la Turchia senza utilizzare le rotte russe, non dobbiamo però dimenticare la presenza di un secondo serbatoio a cui sta lavorando il Turkmenistan che dovrebbe connettere il giacimento di Galkynysh alla costa del Caspio e l’intesa trovata con gli Azeri potrebbe facilitare l’avvio di un’altra grande opera che era rimasta congelata per le frizioni fra i paesi che insistono sul Caspio: il Trans-Caspian Gas-Piperline (TCGP). Le due infrastrutture consentirebbero di avere accesso ad una notevole quantità di gas più vicino e più economico di quello russo. Questo progetto sembra poter essere attuato più facilmente ora che l’Armenia non rappresenta più un impedimento per lo sfruttamento della già esistente infrastruttura del SGC. Si possono, così, aprire nuovi scenari ipotizzando addirittura l’ingresso dell’Iran come fornitore del SGC. La repubblica islamica e il Turkmenistan infatti discutono da tempo di un accordo che prevede la fornitura del gas turkmeno al nord dell’Iran, in cambio dell’esportazione di gas in Turchia tramite il TANAP (parte centrale del SGC). Se pure non è detto che questo scenario sia realizzabile comunque tutto questo ci fa capire che al gioco del gas partecipa anche l’Iran, legata alla Turchia dal gasdotto Tabriz-Ezurum-Ankara, che potrebbe essere rimpiazzato dal Persian pipeline o Iran-Turkey-Europe(ITE) pipeline.
L’Iran dunque mantiene un ruolo importante nella questione energetica e questo potrebbe incidere sulle difficili relazioni con l’Azerbaigian. Infatti se la Repubblica Islamica dal canto suo ha fornito sostegno all’Armenia nella guerra del Nagorno-Karabakh temendo il secessionismo dei numerosi azeri all’interno dei suoi confini su spinta di Baku, l’Azerbaigian ha concesso ad Israele l’insediamento di basi militari sul territorio azero confinante. Le cooperazioni energetiche e l’attuale contesto bellico mediorientale potrebbero aprire una nuova partita.
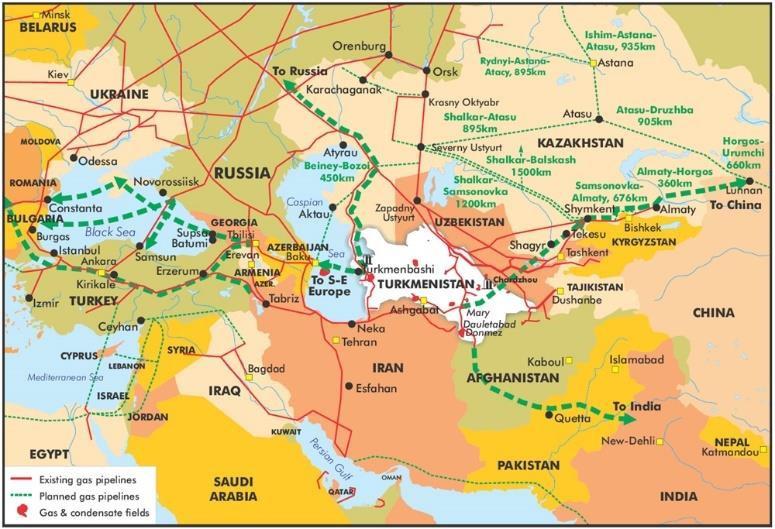

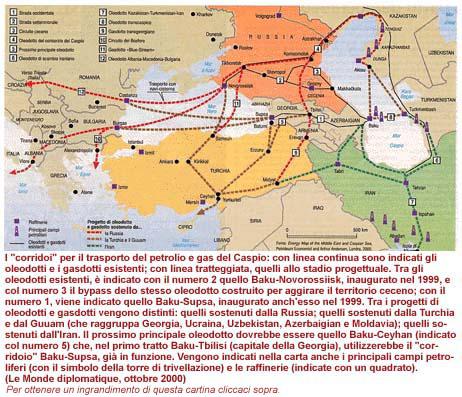
RUSSIA
La Russia ha da anni centinaia di soldati stanziati in Nagorno Karabakh con una missione ufficialmente di peacekeeping (sostenere le autorità locali nel “mantenimento della pace”). Ha rappresentato, pertanto, fino ad ora la potenza economica e militare principale della regione e i suoi stretti rapporti sia con l’Azerbaigian, che con l’Armenia e l’influenza esercitata per decenni in questi territori hanno contribuito a mantenere una “sorta” di pace nell’area.
La Russia ha da sempre mantenuto un ruolo di primo piano nel Caucaso, ed in particolare, nel Nagorno-Karabakh e seppure legata al Trattato di Sicurezza Collettiva con l’Armenia (CSTO), ha spesso venduto armi ad entrambi le parti.
Quando l’Azerbaijan ha attaccato i territori ameni del Karabakh la Russia non è intervenuta militarmente. Le ragioni dell’inazione russa sono dovute sia all’impegno armato dei Russi in Ucraina che ne hanno ridotto la possibilità di intervento, sia al raffreddamento dei rapporti con l’Armenia, per l’avvicinamento del primo ministro Pashinyan all’Occidente. Tuttavia se pure tradizionalmente l’alleanza russa è sempre stata sbilanciata a favore dell’Armenia attualmente l’Azerbaigian è risultato molto più attrattivo essendo uno dei principali esportatori di gas del mondo, quindi molto più ricco della vicina Armenia, con un mercato più grande e prospero sia per i prodotti che per le armi. Nel gennaio 2023 Putin aveva firmato con Aliyev un “accordo di cooperazione”per garantire l’integrità territoriale dei firmatari e il “rispetto di non interferenza negli affari interni dell’altra nazione” evitando di intraprendere attività a danno degli interessi dell’altra parte. Tale clausola è molto importante per Mosca al fine di aumentare la sua influenza sui futuri progetti energetici di Baku, anche al fine di includere il trasporto del gas russo in Europa attualmente vietato. Proprio con l’intento di aggirare le sanzioni il Cremlino ha firmato anche un accordo per la costruzione di una ferrovia con l’Iran che dovrebbe passare lungo la costa del Mar Caspio per collegare i porti russi sul mar Baltico con quelli iraniani nell’Oceano indiano e nel Golfo Persico. È perciò ovvio che non vi è nessuna intenzione di aggravare i rapporti con Baku superando anche la sua non adesione al Trattato di Sicurezza Collettivo e all’Unione Economica Euroasiatica tra gli stati post sovietici, anche perché, a differenza di Georgia, Ucraina e Armenia non ha rotto i rapporti con Mosca e al momento non ha espresso alcun desiderio di aderire alla Nato. Tutto ciò ha rafforzato il rispetto reciproco spingendo pertanto il Cremlino a non ostacolare la vittoria azera nel tentativo di sottrarre Baku all’Occidente e all’orbita turca. Già per tutta la durata della seconda guerra del Nagorno Karabakh nel 2020 Mosca aveva mantenuto una posizione prudente e pragmatica, ribadendo la sua neutralità. Infatti nonostante l’intensificarsi delle richieste di supporto da parte armena, aveva negato l’intervento della CSTO ritenendo i territori in questione di fuori dei confini armeni e spingendo per una soluzione pacifica. il Cremlino,dunque, che in tutti questi anni si è sempre presentato come la principale potenza mediatrice del Gruppo OSCE di Minsk (la cui presidenza è tripartita tra Washington, Parigi e Mosca), si era adoperato per preservare quel ruolo di potenza super partes, decisivo per la risoluzione delle dispute nella regione.
Era stato proprio l’intervento diplomatico russo ad aver permesso la firma il 9 novembre 2020 di un accordo per il-cessate-il-fuoco in dieci puntidove, oltre alle divisioni territoriali (vantaggiose per l’Azerbaigian), era previsto il dispiegamento di circa duemila militari russi impegnati in una missione di peacekeeping nel corridoio di Lachin fino ad Aghdara, nell’estremo nord, per almeno cinque anni, con un’estensione automatica di altri cinque a discrezione di Yerevan e Baku, accordo che, tuttavia, lasciava aperta la questione dello status legale del Nagorno Karabakh senza un preciso piano per la ricostruzione o la stabilizzazione dell’area.
Indubbiamente in quella fase l’accordo aveva rappresentato una vittoria per Mosca sia per aver ottenuto un congelamento del conflitto nel Caucaso sia per essere riuscita a mantenere intatte le relazioni con entrambi i paesi: aveva impedito da un lato la capitolazione definitiva di tutta l’area in mano azera, sostenendo la causa armena, dall’altro invece, aveva consentito a Baku sufficiente libertà di manovra nella conquista di importanti zone del Karabakh e si era garantita, se pur limitatamente ai cinque anni successivi una presenza militare diretta nella regione. Momentaneamente aveva messo all’angolo anche il Presidente armeno, uomo dell’occidente, dimessosi a seguito delle pressioni interne.
Era riuscita, inoltre ad estromettere dagli accordi diplomatici la Turchia, e dunque dal futuro assetto nella regione dove invece veniva confermato il suo ruolo decisivo sul piano sia diplomatico, che militare ed economico post-bellico.
A seguito dell’attuale guerra lampo però la situazione è cambiata e Mosca sembra aver perso buona parte della sua leadership.
ARMENIA
Il 27 settembre le autorità armene del Nagorno karabakh hanno dichiarato la dissoluzione dell’autoproclamata repubblica dell’Artsakh. La repubblica armena conseguentemente si è trovata a dover accogliere le oltre 100000 persone sfollate provenienti in gran parte dalla regione del Sunik, nel Sud del Paese, rispetto alle quali il governo armeno si è assunto la responsabilità di fornire protezione con il supporto dell’UNHCR (Agenzia Onu per i rifugiati) e di altre agenzie ONU e ONG. Per un paese di 2,8 milioni di persone e un’economia debole non sarà facile sostenere una tale condizione continuando a fornire assistenza ai profughi. È indubbio che la situazione dell’Armenia sia molto difficile sia per quanto riguarda il contesto geopolitico che si andrà a configurare con il distacco dalla Russia e l’avvicinamento agli Usa, sia per i problemi interni: sono molte infatti le tensioni governative e le proteste di piazza per la sconfitta e la svendita del Nagorno Karabakh la cui responsabilità è attribuita alla politica di Pashinian, pesantemente accusato anche dalla congregazione lobbistica della diaspora armena.
Il presidente Pashinian è di fatto la chiave di volta rispetto alle alleanze. L’ex giornalista sin dagli anni universitari nel 1998 è stato un attivista e oppositore del governo filorusso. Nel 2008 con l’accusa di aver organizzato disordini di piazza contro i risultati delle elezioni presidenziali vinte da Sargsyan, dopo una latitanza di un anno, viene condannato a 7 anni di reclusione ma sconta solo 11 mesi di carcere a seguito di una amnistia. Nel 2018 ha capeggiato le manifestazioni pacifiche a cui è seguito lo sciopero generale (Rivoluzione di velluto) che contrastavano il terzo mandato, non ammissibile dalla costituzione armena, del Presidente Sargsyan, destituito il 23 aprile. L’8 maggio Pashinyan è stato eletto Primo Ministro e il 21 giugno 2021 a seguito di elezioni parlamentari Presidente dell’Armenia con il 51% dei voti.
Durante il suo mandato per rendere più attraente il settore informatico agli investitori stranieri ha concesso un importante sostegno economico statale ammontante a diversi milioni di dollari in particolare a cinque grosse aziende con doppia sede a Erevan e negli USA, trattandosi di imprenditori nativi in Armenia ma con affari oltreoceano. Appare ovvio come l’economia armena già da tempo abbia varato verso capitali americani proprio grazie al solido appoggio di un uomo come Paschian.
Non meravigliano dunque le scelte politiche degli ultimi tempi tutte volte ad allontanarsi dalla Russia e a stabilire un nuovo legame con l’Occidente, quali la partecipazione della moglie del premier, Anna Hakobyan, a settembre 2023 al Summit annuale of First Ladies and Gentlemen a Kiev organizzato dalla moglie di Zelensky, il ritiro del proprio ambasciatore presso la CTSO (Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, alleanza militare dei paesi dell’ex URSS), le esercitazioni militari di settembre in Armenia con la Nato, chiamate “Eagle Partner. Questo quadro di collaborazione militare è in realtà datato ma era la prima volta che l’Armenia partecipava con queste modalità ad esercitazioni con gli americani. Questi eventi hanno prodotto una dura reazione da parte di Mosca attraverso la portavoce del ministero degli esteri Maria Zakharova che ha pesantemente criticato il Primo Ministro armeno. Un altro capitolo di scontro è legato alla guerra Ucraina-Russia e riguarda la ratifica in ottobre della partecipazione dell’Armenia allo Statuto di Roma, al fine di garantire il ricorso alla “Corte penale internazionale” nel caso di una eventuale invasione dell’Armenia, ratifica che ha una ulteriore ricaduta negativa nei rapporti con la Russia in quanto potrebbe portare come conseguenza “l’obbligo di arresto” del presidente Putin qualora andasse in visita in Armenia.
I russi perciò lo accusano di collaborazionismo con l’Occidente evidenziando come egli abbia sabotato l’attuazione degli accordi 2020-2022, che a loro detta avrebbero potuto compiere passi significativi in termini di negoziazione di un trattato di pace, con la delimitazione del confine e sblocco delle comunicazioni regionali che avrebbero rappresentato ulteriori fattori di sicurezza. Inoltre lo accusano, in occasione degli incontri di Praga e Bruxelles sotto l’egida dell’UE, di aver riconosciuto l’integrità territoriale dell’Azerbaigian senza menzionare i diritti e la sicurezza degli Armeni del Karaback.
Paschiyan dal canto suo cerca invece di scaricare la colpa su Mosca per assolvere se stesso dalla responsabilità del fallimento in politica interna ed estera. Pur essendo l’attuale governo dichiaratamente filostatunitense una parte del governo armeno ma anche della popolazione è ancora favorevole all’alleanza russa ed è proprio per arginare queste spinte che Nancy Pelosi è volata in Armenia e l’UE attraverso la Francia, che è il paese europeo che ospita la più grande comunità della diaspora armena, ha inviato attrezzature militari per la difesa dell’Armenia in caso di attacco azero.
Indubbiamente la situazione dell’Armenia è estremamente difficile: il vecchio alleato russo l’ha abbandonata pur mantenendo ancora le sue basi militari e l’Occidente non è particolarmente coinvolto nella crisi umanitaria in atto ma piuttosto è interessato all’andamento delle più ampie dinamiche geopolitiche e all’approvvigionamento delle fonti energetiche (in particolare l’Unione Europea), ragion per cui l’Armenia rischia di restare isolata, schiacciata tra Turchia e Azerbaigian.
Il presidente Paschinyan mantiene ancora dei consensi anche se ci sono molti dissidenti una parte dei quali lo disprezza per la mancanza di spessore politico, una parte lo cataloga come un uomo venduto a Soros, un’altra addirittura come delfino di Mosca. Quest’ultima affermazione appare molto contraddittoria e inverosimile ma sembra essere derivata dall’ipotesi plausibile del disegno Cremlino di annettere l’Armenia alla Federazione russa una volta divisa e ridotta ai minimi termini dall’avanzata azera. Di fatto Mosca confidava nella dimissione di Pashinyan sconfessato dal suo popolo a seguito della sconfitta nella guerra del 2020, per sostituirlo con un partner più affidabile filorusso, ma ciò non è avvenuto.
La situazione attuale è molto cambiata, l’egemonia russa è venuta meno e purtroppo non è decaduta la possibilità di un altro conflitto questa volta direttamente contro l’Armenia. Secondo il portale d’informazione “Politico” a inizio ottobre il segretario di Stato americano Antony Blinken avrebbe avvisato un piccolo gruppo di parlamentari sulla possibilità che l’Azerbaijan potesse procedere presto ad un invasione dell’Armenia, smentito poi da Biden ma sta di fatto che il 23 ottobre sono iniziate le prime esercitazioni militari azero-turche, con 3000 militari, 130 veicoli blindati e 100 pezzi di artiglieria “Mustafa Kemal Atatuturk-2023” in Karabakh e Nakhichevan.
Questo territorio rappresenta un altro nodo cruciale nei rapporti tra i paesi caucasici. Infatti la posizione geografica della repubblica autonoma del Nakhichevan, enclave azera, confinante con Armenia, Turchia, Iran, la rende appetibile sia a Erdogan che a Aliyev, che ne ha reclamato la sovranità, per la possibilità di creare un corridoio commerciale che colleghi l’Azerbaijan e la Turchia passando per l’Armenia del sud (corridoio di Zangezur). La riapertura delle frontiere consentirebbe l’afflusso di beni di produzione in particolare turca ma anche azera e attraverso i nuovi progetti infrastrutturali comuni l’apertura della rotta verso la Cina, entrando a far parte della nuova via della seta.
Questo è un progetto datato che oggi può essere effettivamente realizzato; infatti già nel marzo 2022 nell’ambito della 15ma riunione della Commissione intergovernativa per gli affari economici commerciali e umanitari tra Azerbaijan e Iran i governi dei due paesi firmarono un memorandum d’intesa sull’instaurazione di nuovi collegamenti di comunicazione tra il distretto economico dello Zangezur orientale della repubblica dell’Azerbaigian e la repubblica del Nakhchivan attraverso il territorio dell’Iran. Il fine ultimo doveva essere la costruzione di un corridoio internazionale per i trasporti e l’elettricità nell’ottica di realizzare un nuovo corridoio polivalente in Eurasia comprensivo di strade, ferrovie, linee elettriche e connessioni digitali. Oggi l’Armenia non può più opporsi a questo progetto come ha fatto per anni, per cui non è totalmente da escludere la possibilità che l’Azerbaigian, approfittando del contesto internazionale e della debolezza armena, attacchi il Sunik, la suddetta regione nel sud dell’Armenia, per garantirsi il controllo diretto di questo corridoio.
È notizia dell’ultima ora, tuttavia, sulla base di una dichiarazione di Pashian in un discorso al forum economico internazionale a Tbilisi, che il suo paese firmerà un accordo di pace con l’Azerbaigian a novembre.
Vedremo se sarà possibile e a quali condizioni: forse “regalerà” un altro pezzo di Armenia agli Azeri, riducendo di gran lunga il territorio del suo paese rendendo più appetibile agli azeri per l’annessione di tutta l’Armenia (Aliyev ha definito Erevan” una città storicamente azera”) o si farà da parte lasciando di nuovo il campo ai russi che potrebbero usare la questione del Nakhicevan come moneta di scambio in termini di sicurezza per giustificare un loro ravvicinamento. Tutto dipenderà dagli accordi delle potenze in campo e dalla situazione generale, tant’è che a seguito della guerra in Palestina sembra (da fonti russe) che l’Azerbaigian sia interessato a riaffermare il vecchio progetto con l’Iran e dunque a deporre l’ascia di guerra contro l’Armenia. Molto dipende da come evolverà la situazione in Medio Oriente e dal tipo di alleanze che si profileranno.

USA – NATO
Importanti segnali sembrano mostrare che l’alleanza atlantica sia pronta a riempire vuoti strategici lasciati dalla Russia. Il 3 settembre il presidente del Comitato Europeo per lo sviluppo della Nato, l’austriaco Gunther Fehilinger ha invitato apertamente l’Armenia ad abbandonare la CSTO per passare poi alla Nato. Pashian ha detto “È stato un errore strategico affidarci alla Russia per la difesa del paese. L’Architettura di sicurezza dell’Armenia è legata alla Russia per il 99,999% ma oggi vediamo che la Russia stessa ha bisogno di armi. Perfino se desidera farlo la Russia non può venire incontro ai bisogni dell’Armenia”. L’avvicinamento di Pashinyan peraltro è stato caratterizzato anche da aiuti umanitari per l’Ucraina.
Il 26 settembre è giunta in Armenia Samanta Power (direttrice dell’US Agency for International Development USAID) con il Vicesegretario del Dipartimento di Stato Yuri Kim per visitare il campo di accoglienza di Kornidzor e ha dato la disponibilità degli USA a supportare la sovranità e integrità territoriale, l’indipendenza e la democrazia dell’Armenia nonché per dare aiuto ai bisogni umanitari.
La funzione di Washington ha anche evocato l’avvio “di osservatori indipendenti e organizzazioni umanitarie nella regione per la necessità dei civili”. Tra le righe il messaggio significa che gli USA intendono sostituirsi alla Russia come nume tutelare per l’Armenia: a tale scopo, affermando le loro consuetudini politiche, hanno offerto un pacchetto di 11,5 milioni di euro, addirittura il doppio di quelli promessi dall’UE.
In realtà gli USA da tempo si stanno adoperando per allontanare la Russia anche dal territorio del Caucaso, tant’è che le relazioni di partenariato Armenia-NATO risalgono addirittura al 1992, quando l’Armenia si è unita al Consiglio di Cooperazione del Nord Atlantico, in seguito ribattezzato Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico (Armenia è membro dell’EAPC dal 1997). La cooperazione dell’Armenia con la NATO si è gradualmente ampliata da quando l’Armenia ha aderito al partenariato per la pace nel 1994.
Le collaborazioni riguardano diverse sfere e in primis la sfera della difesa e della sicurezza: dal 2004 le unità armene partecipano alle operazioni di pace e questo ha permesso al paese di diventare da un consumatore ad un collaboratore della sicurezza. A partire dal 2006 il dialogo politico e la cooperazione di partenariato in vari settori si sono ulteriormente sviluppati includendo anche:
a) la pianificazione e la preparazione dell’emergenza civile per migliorare le capacità di soccorso in caso di calamità ed affrontare efficacemente le catastrofi naturali e varie altre minacce. A tal fine, attraverso una stretta collaborazione con il Centro di Coordinamento della Risposta ai Disastri Euro-Atlantico della NATO (EADRCC), l’Armenia intende sviluppare e rafforzare ulteriormente la propria gestione delle crisi e le capacità di protezione civile.
b) la diplomazia pubblica. L’Armenia infatti aumenta regolarmente la consapevolezza del rapporto di partenariato Armenia-NATO attraverso eventi diplomatici pubblici. A tale scopo sono stati istituiti gli eventi annuali della “Settimana della NATO”.
Questa breve sintesi del partenariato tra Armenia e Nato dimostra come la strada verso l’Occidente sia stata tracciata da lungo tempo attraverso personaggi “costruiti” dagli USA come Pashinian anche attraverso quelle rivoluzioni pacifiche che qui prendono il nome di “rivoluzioni di velluto” altrove di “rivoluzioni arancioni.” Si tratta pur sempre di movimenti orchestrati al fine di mettere in piedi governi filoamericani. Sarà da vedere se riusciranno nell’intento o se Mosca con la sua politica opportunistica sarà in grado di recuperare il terreno. Sembra infatti che vi sia un sorprendente aumento del 48,8% di turisti russi in Armenia e che circa 108.000-110.000 russi nel 2022 si sarebbero trasferiti nel paese ed inoltre sarebbero state aperte 2500 società con soci russi nonché 4000 aziende individuali. Dati che fanno riflettere.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Si può dunque ribadire che la guerra in Nagorno Karabakh va inquadrata nell’ambito dei conflitti esplosi nella vasta area che va dal Caucaso, scende all’Iran e alla Turchia, fino al Golfo Persico con la Penisola Arabica da una parte e la Siria, il Libano, la Giordania e Israele dall’altra. La posta in gioco nel Caucaso va, dunque, ben al di là del conflitto regionale esaminato essendo inserita nella guerra dei tubi del gas e delle rotte energetiche che rappresenta pertanto un aspetto dello scontro imperialistico tra USA Cina e Russia. Quindi l’intreccio che ruota attorno al gas ci fa comprendere i reali interessi che muovono i vari conflitti – naturalmente anche quello Armenia e Azerbaigian – dove i rapporti tra i paesi cambiano opportunisticamente e così le alleanze.
L’arco di crisi che parte dall’Ucraina, continua nel Mar Nero e dal Caucaso Meridionale va al Medio Oriente coinvolge fortemente l’Europa che guarda con molta attenzione agli sviluppi in questa area, pur mantenendo una distanza di sicurezza. L’Azerbaigian colosso dell’energia che commercia sia gas che petrolio estratto soprattutto dal mar Caspio rappresenta un flusso di gas vitale per l’intera Europa, a maggior ragione dopo la demolizione del gasdotto North Stream e del blocco russo attraverso i gasdotti ucraini. Il conflitto Azero-Armeno mette in seria discussione questa fonte di approvvigionamento. Difficilmente, infatti gli Stati Uniti concederanno agli alleati di smarcarsi ed in quest’ottica vanno lette le sanzioni contro l’Azerbaigian che nulla hanno a che fare con il sostegno all’Armenia assediata. Tutto ciò assume sempre più l’aspetto di una guerra energetica contro l’Europa che rischia, così, la desertificazione industriale a favore degli USA, volti a rilanciare la loro economia, come anche dichiarato dal Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Russo Medvedev: “gli Stati Uniti approfittano della difficile situazione in Europa per avviare la reindustrializzazione a spese degli altri”.
L’imperialismo USA minacciato dall’ascesa di altre potenze imperialiste quali la Cina si mostra ancora di più aggressivo e guerrafondaio, conducendo guerre economiche contro paesi non allineati, colpendo i popoli, gli unici che pagano sempre sulla loro pelle tutto questo, con sanzioni, embarghi e guerre. La guerra USA-NATO-Russia è come abbiamo potuto vedere una guerra per il controllo dei mercati finanziari, delle materie prime, delle reti, dei trasporti, dove l’ottica è quella di isolare la Russia, staccandola prima di tutto dall’Ucraina ed accerchiandola; come più volte abbiamo detto anche la guerra nel Nagorno-Karabakh rientra in questo progetto ma Washington vuole andare oltre: vuol far cadere la Russia per circondare e affamare la Cina, suo maggiore bersaglio. Le relazioni commerciali tra Russia e Cina infatti si sono molto intensificate garantendo a quest’ultima l’accesso a risorse russe indispensabili per l’ulteriore sviluppo di una potenza mondiale con una popolazione di 1 miliardo e mezzo di persone. L’estensione di un conflitto in Medio Oriente verso cui gli USA stanno spingendo (vedi provocazioni continue ad Aleppo e a Damasco), va nella direzione di creare un arco di crisi gigantesco in Oriente che possa aprire la strada all’annientamento della Russia per poter poi aggredire il più grande nemico la Cina nella riaffermazione dell’impero americano.
A cura della Commissione Internazionale Unione di Lotta
per il Partito comunista
https://unionedilottaperilpartitocomunista.org – unionedilottaperilpartitocomunista@tutanota.com
Dicembre 2023
Haiti… verso una nuova occupazione militare
Una risoluzione ONU dà il via libera all’invio di una forza multinazionale di polizia ad Haiti

Il 2 ottobre 2023 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato, con tredici voti favorevoli e due astensioni (Russia e Cina), una risoluzione con cui l’ONU dà il via libera all’invio di una forza multinazionale di polizia ad Haiti.
La discussione a New York in merito alla costituzione di un contingente internazionale armato da distaccare nell’isola caraibica era iniziata, dietro le pressioni di USA e Canada – appoggiati, di volta in volta, da altri paesi del continente americano (come Ecuador e Messico) – circa un anno fa ma diversi ostacoli di natura politica ed organizzativa avevano causato il continuo rinvio della decisione finale.
La motivazione che ha spinto il Consiglio di Sicurezza a promuovere questa operazione di polizia internazionale – che però non agirà, paradossalmente, sotto le insegne dell’ONU – è stata quella di ripristinare l’ordine pubblico e la sicurezza nell’isola ma soprattutto nella capitale Port au Prince, dove imperversano bande criminali che hanno assunto di fatto il controllo delle principali vie d’accesso, di interi quartieri, di zone strategiche come il porto ed il terminal petrolifero di Varreux.
Ma prima di entrare nel merito della difficile situazione che sta attualmente attraversando l’isola caraibica, può essere forse utile ripercorrere, sia pure a grandi linee, alcuni passaggi della sua complessa storia.
Dalla colonizzazione spagnola al dominio francese
La “tranquillità” di Haiti ebbe fine nel dicembre del 1492 quando il genovese Cristoforo Colombo, al servizio del Re di Spagna, approdò sulle coste di questa isola che i conquistatori spagnoli “battezzeranno” con il nome di “Hispaniola”, cioè “Spagnola”.
La popolazione indigena, stimata, secondo fonti dell’epoca, intorno ai due milioni di individui – ma il dato non è certo ed è stato in diversi studi considerato eccessivo – guardò ai nuovi arrivati con curiosità mista a sospetto. Ed in effetti essa conobbe assai presto le violenze e le angherie di ogni genere che questi “strani” uomini portati dal mare cominciarono a perpetrare nei suoi confronti.
Nonostante diverse sollevazioni, represse dagli invasori con inaudita ferocia e con la benedizione dei missionari cattolici giunti al seguito delle milizie spagnole, la popolazione indigena venne completamente sottomessa.
Ridotti ad una condizione di totale schiavitù, costretti a lavorare senza sosta – compresi i bambini – nelle piantagioni e nelle miniere, flagellati dalla diffusione di malattie importate dagli spagnoli e sconosciute al sistema immunitario degli indios, la popolazione locale scese nel 1506 a non più di 60000 sopravvissuti, fino alla sua definitiva estinzione datata intorno al 1540.
La mancanza di “manodopera” – l’afflusso di schiavi africani verso le colonie spagnole dell’area caraibica procedeva a rilento -; la colonizzazione di nuove e ricche terre (Messico e Perù in particolare) che attirarono maggiormente l’attenzione dei conquistadores spagnoli; l’aggressività manifestata sulle coste occidentali di Hispaniola da una pirateria che agiva sotto la protezione della rivale Francia, indussero la Spagna a ritirarsi sempre più verso la zona orientale dell’isola (la futura Repubblica Dominicana). Infine, nel 1697, il paese iberico cedette definitivamente la contesa parte occidentale alla Francia.
L’avvento della Francia quale potenza dominante segnò, relativamente a quella porzione di isola che solo nel 1801 acquisirà la denominazione di “Haiti” (“Montuosa”), un deciso salto di qualità nello sfruttamento coloniale.
I nuovi padroni dell’isola rilanciarono tanto l’attività mineraria quanto e soprattutto la produzione agricola -in particolare le piantagioni di caffè, di zucchero, di tabacco e di altri prodotti alimentari richiesti sui mercati europei- anche attraverso una massiccia “importazione” di schiavi africani che, vivendo e lavorando in condizioni disumane, morivano in gran numero, imponendo la necessità di un continuo ricambio.
Inoltre è con il dominio francese che si afferma nell’isola una più rigorosa stratificazione sociale, basata sull’appartenenza razziale e sul potere economico.
La società “haitiana” venne strutturata, di fatto, sulla base di quattro diversi gruppi:
1)i grandi bianchi (“grand blanc”), che raggruppava i funzionari del governo francese e i grandi proprietari terrieri. Di fatto essi costituivano la ricca borghesia schiavista, la cima della piramide della società coloniale;
2) i piccoli bianchi (“petit blanc”), cioè i bianchi europei non latifondisti ma attivi nel commercio e nell’artigianato. Era questo un gruppo spesso schiacciato tra i soprusi commessi a loro danno dai grandi bianchi e le spinte provenienti dal basso, soprattutto dai mulatti;
3) i mulatti e i neri liberi, quindi i nati da genitori di origini etniche diverse o ex schiavi i cui padroni avevano, per vari motivi, concesso loro la libertà. Si trattava di un gruppo molto conflittuale al proprio interno, sia dal punto di vista della ricchezza di cui molti di loro (soprattutto tanti mulatti) potevano disporre, sia dal punto di vista della maggiore o minore quantità di sangue nero che scorreva nelle loro vene (più chiaro era il colore della loro pelle, maggiore era la possibilità di vivere e di emulare i lussuosi usi e costumi dei dominatori francesi;
4) gli schiavi, decisamente la componente più numerosa nella società coloniale dell’isola caraibica. La proporzione -probabilmente per difetto- con i due gruppi assommati di bianchi era di 20 a 1; l’80% degli schiavi, provenienti da diverse zone dell’Africa, lavorava nelle piantagioni. Proprio l’incontro e la fusione di differenti idiomi africani, portarono alla nascita del creolo haitiano, la lingua ancor oggi parlata, oltre al francese, dalla popolazione di Haiti.
A questi quattro gruppi ne va aggiunto un quinto, i cimarroni, che raggruppava gli schiavi fuggiti dai loro padroni e che trovavano rifugio nelle zone montuose all’interno del paese. Questi schiavi ribelli erano soliti organizzarsi in libere comunità, da dove partivano attacchi armati ai latifondisti bianchi ed alle loro proprietà ed appelli alla ribellione rivolti agli schiavi ancora in catene.
Questa rigida organizzazione sociale entrò infine in crisi a seguito di quanto accadde nella madrepatria alla fine del ‘700: la Rivoluzione Francese del 1789.
La Rivoluzione francese ad… Haiti
Sebbene le notizie su quanto stesse avvenendo in Francia giungessero inevitabilmente in ritardo nei territori francesi d’oltreoceano, le diverse e convulse fasi della rivoluzione finirono comunque per scardinare in profondità le basi della società razzista e schiavista della colonia.
Il primo a subirne gli effetti fu il gruppo dei grandi bianchi che non solo riprodusse al proprio interno la contrapposizione tra fautori della monarchia e sostenitori delle varie fazioni della borghesia rivoluzionaria, ma si spaccò anche sulla richiesta di indipendenza della colonia dalla Francia. Mentre i grandi latifondisti ed i ricchi commercianti invocavano la secessione, sperando in tal modo di ampliare la rete internazionale delle loro relazioni commerciali – sottraendole al monopolio francese – e di assumere il controllo totale del commercio degli schiavi, i funzionari statali e le gerarchie militari si opponevano alla separazione dalla madrepatria.
Ma, in una sorta di effetto a cascata, le conseguenze degli eventi francesi si manifestarono ben presto in tutti gli altri gruppi sociali: dai piccoli bianchi – che assunsero la denominazione di “patrioti” – ostili sia ai grandi bianchi che ai mulatti e ai neri liberi – che reclamavano entrambi, a loro volta, uguali diritti a quelli dei cittadini francesi – fino agli schiavi neri che, chiedendo invano l’abolizione della schiavitù, infine si ribellano in armi nell’agosto del 1791.
Quindi, mentre la lontana colonia era attraversata da tensioni e violenze sia a sfondo politico che sociale, lo scoppio della guerra in Europa tra la Francia rivoluzionaria e l’Inghilterra complicò ulteriormente la situazione nell’isola caraibica che fu invasa dagli inglesi e, contemporaneamente, dovette fronteggiare il pericoloso ritorno degli spagnoli.
A questo punto si aprì per Haiti una fase particolarmente caotica della sua storia, in cui i vari gruppi – o, spesso, solo segmenti di questi – che avevano caratterizzato la vita politica e sociale haitiana fino a quel momento, si resero protagonisti, anche d’intesa con le varie potenze coloniali in lotta tra loro nel territorio haitiano, di un susseguirsi di spregiudicate alleanze o di fragili accordi (dall’autogoverno dell’isola all’abolizione totale o parziale della schiavitù), sistematicamente violati a favore di nuove “combinazioni” politico-militari o di ambizioni personali di leader locali.
Infine, un esercito haitiano guidato da ufficiali prevalentemente di origine mulatta ma composto anche da soldati neri e da gruppi di bianchi costrinse al ritiro da Haiti gli invasori inglesi e spagnoli ma dovette poi far fronte nel 1802 ad una spedizione militare francese con cui la madrepatria cercò di recuperare il controllo totale della colonia e di ripristinare la schiavitù.
Dopo alterne vicende gli haitiani ebbero finalmente la meglio sui francesi nel dicembre del 1803. Il 1° gennaio 1804 venne proclamata l’indipendenza di Haiti, il primo Stato indipendente dell’America Latina ed il primo Stato governato da politici neri, il generale Jean Jacques Dessalines, ex schiavo nero nelle piantagioni di proprietà dei latifondisti bianchi, divenne il primo presidente della Repubblica haitiana.
La travagliata indipendenza
Nei decenni che seguirono la dichiarazione d’indipendenza, il Paese fu percorso da violente lotte intestine che portarono addirittura, per diversi anni, ad una divisione del territorio haitiano tra un “impero” nel nord ed una repubblica filo-bolivariana nel sud dell’isola.
Ricostituitasi nel 1820 l’integrità territoriale sotto la bandiera della Repubblica, Haiti dovette fare i conti sul piano internazionale con una condizione di blocco diplomatico e commerciale. D’altronde uno Stato costituitosi da una ex colonia, governata da ex schiavi, sostenitore – tramite l’invio di armi, denaro e volontari – delle lotte di liberazione condotte in America Latina da Simòn Bolivar, non poteva non essere inviso a stati schiavisti e coloniali come gli Stati Uniti, la Spagna, il Portogallo, ovviamente la Francia e, in relazione alle proprie convenienze, l’Inghilterra.
La Francia riconobbe l’indipendenza di Haiti – senza peraltro sottoscrivere alcun trattato ufficiale di pace – solo nel 1862 e solo dopo aver imposto all’isola un esoso risarcimento per le piantagioni espropriate o distrutte dagli schiavi nel corso della lotta per l’indipendenza e l’abolizione della schiavitù. Per ottemperare a questo impegno i governi haitiani furono costretti ad indebitarsi pesantemente con diverse banche statunitensi, francesi e, soprattutto, tedesche. (Ancor oggi si ritiene che i problemi di sottosviluppo di Haiti derivino innanzitutto da quel “debito”, estinto negli anni a venire ma a prezzo di grandi sacrifici per la popolazione haitiana).
Seguì quindi il riconoscimento ufficiale della Gran Bretagna. Nel 1864 ci fu quello dello Stato della Chiesa che aveva subito anch’esso espropriazioni, distruzioni e perdita di potere nell’isola ribelle. Il riconoscimento degli Stati Uniti avvenne nel 1862, sotto la presidenza Lincoln e nel corso della guerra civile americana, che si concluse con l’abolizione della schiavitù anche in quel paese. Contrastati – talvolta dati e poi ritirati – furono invece i riconoscimenti di altri paesi dell’area latino-americana, molto influenzati nelle loro decisioni dalle pressioni esercitate dalla Chiesa cattolica.
I mancati riconoscimenti internazionali ebbero come immediata conseguenza quella di isolare Haiti sul piano commerciale, privandola dei tradizionali sbocchi di mercato per la sua produzione agricola, in faticosa ripresa dopo le vicende belliche ed il terremoto sociale che avevano sconvolto la vita dell’isola negli ultimi decenni.
Inoltre il ricavato dall’esportazione delle merci – che avveniva più grazie al contrabbando che non a regolari transazioni commerciali – veniva convogliato dalle autorità haitiane, che temevano possibili aggressioni da parte della Francia o di altre potenze coloniali e schiaviste, al rafforzamento militare del Paese.
Alla fine del 1821 una sollevazione antispagnola nella parte orientale di “Hispaniola” consentì al nuovo presidente di Haiti, il nero Boyer, di intervenire vittoriosamente a sostegno degli insorti. L’isola fu quindi riunificata. Ma gli haitiani, comportandosi più da invasori che da liberatori, finirono per ridare fiato al sentimento nazionalista dei domenicani i quali, dopo 22 anni di occupazione militare, riuscirono a cacciare via l’esercito haitiano e a proclamare l’indipendenza della Repubblica Domenicana.
La ventennale presenza haitiana nella zona domenicana consentì il raggiungimento di importanti risultati – tra cui una estesa riforma agraria e la definitiva abolizione della schiavitù – ma concorse anche ad inasprire fortemente i rapporti tra le due diverse popolazioni. Tanto che ancor oggi, a distanza di oltre 180 anni da quegli eventi, le relazioni tra i due paesi confinanti sono segnate da ricorrenti scontri diplomatici e da tensioni anche sul piano militare.
Tra il 1844 ed il 1915 Haiti sprofondò in una situazione di permanente instabilità istituzionale e di dilagante violenza politica. Si succedettero alla guida della Repubblica – salvo una parentesi monarchica nel decennio 1849-1859 – numerosi presidenti – solo tra il 1908 ed il 1915 ben nove – per la gran parte rovesciati, anche a poche settimane dal loro insediamento, da sommosse popolari ma soprattutto da colpi di Stato militari.
Ben pochi di questi presidenti si avviarono sulla via di riforme politiche ed economiche che apportassero sensibili miglioramenti alle condizioni di vita dei vari strati della popolazione, preoccupati piuttosto – ma quasi sempre inutilmente – di non inimicarsi l’esercito che si presentava sempre più come il baricentro della vita politica haitiana.
Il neocolonialismo statunitense
Il 1915 costituisce per Haiti un nuovo punto di svolta nella sua storia.
In un contesto, quindi, di continue turbolenze istituzionali e politiche, la struttura sociale del paese caraibico si era intanto riassestata – pur con una rigidità relativamente minore rispetto al passato – intorno a quattro gruppi fondamentali:
- i bianchi, eredi dei “grand blanc” della società coloniale schiavista. Sopravvissuti – pochi – alle durissime lotte dei decenni precedenti, alcuni di loro detenevano ancora la proprietà di estese piantagioni e mantenevano un forte potere economico;
2)una influente borghesia mulatta – cui si affiancavano gruppi di discendenti di ex neri liberi e di ex schiavi – particolarmente radicata nella capitale Port-au-Prince e nei più importanti centri costieri dell’isola e dedita al commercio ed alle libere professioni (soprattutto legali);
3) una élite nera, proveniente dalle famiglie già schiave, che aveva trovato la sua rivalsa sociale entrando nelle scuole militari e contribuendo alla formazione dei quadri dell’ufficialità dell’esercito haitiano. Questi militari neri esercitavano una forte presa su una buona parte della popolazione di colore che veniva talvolta manipolata e indotta a ribellioni che avevano come obbiettivo la rimozione di un presidente sgradito alle forze armate;
4) la stragrande maggioranza della popolazione nera che, già schiava, si trovava ora in uno stato di formale libertà ma di sostanziale schiavitù salariata. Alcuni gruppi di lavoratori neri, al fine di sfuggire a questa condizione di sfruttamento, cercarono, unendo le forze, di formare autonome comunità contadine, scontrandosi con l’ostilità degli altri gruppi sociali e spesso con la repressione governativa.
In questo quadro politico e sociale si inserirono le politiche neocoloniali di diverse potenze straniere
Indebolitasi la presenza francese, fu innanzitutto la Germania a cercare di prendere il suo posto nell’area caraibica. Approfittando di alcuni incidenti diplomatici, navi da guerra tedesche presero a stazionare già nel 1897 nel porto di Port-au-Prince mentre compagnie commerciali del paese europeo, dopo aver stretto accordi con la locale borghesia mulatta, assunsero di fatto il controllo del traffico marittimo haitiano.
Ciò pose in allarme gli Stati Uniti che, dopo aver subito nel 1891 un rifiuto alla richiesta di concessione di uno scalo marittimo nel paese caraibico, tornarono alla carica, riuscendo nel 1908 alcune compagnie statunitensi ad ottenere l’appalto per la costruzione di ferrovie e, soprattutto, l’ampliamento delle piantagioni di banane attraverso l’espropriazione di terre alle locali comunità contadine (un provvedimento governativo che fu appoggiato anche dai latifondisti haitiani che speravano di trarvi a loro volta dei vantaggi).
Nel 1910 la National City Bank acquisì una quota significativa della Banca centrale di Haiti, fino a quel momento interamente controllata dal Ministero del Tesoro.
Ma il controllo tedesco sull’intermediazione commerciale continuò a rappresentare un grosso limite per i profitti statunitensi almeno fino al 1915, quando, approfittando delle difficoltà della Germania a seguito dello scoppio in Europa del Primo Conflitto Mondiale, gli Usa non esitarono ad invadere Haiti.
Nel giro di poche settimane i marines assunsero il controllo dell’intera isola. Gli Stati Uniti fecero eleggere, da un riluttante Parlamento haitiano, un nuovo presidente a loro gradito, Philippe Dartiguenave, che non esitò a sottoscrivere un trattato con cui l’amministrazione del Paese veniva condivisa con gli occupanti, che potevano anche esercitare un diritto di veto sulle decisioni governative, mentre il 40% circa delle entrate finanziarie dello stato passavano sotto il controllo diretto degli Usa. L’esercito venne sciolto e fu istituita una forza di polizia comandata da ufficiali statunitensi.
Nel 1917 il Presidente Dartiguenave sciolse, “manu militari” statunitense, la Camera haitiana che aveva rifiutato di approvare una Costituzione ispirata da Washington e che comunque venne promulgata l’anno successivo dopo un referendum cui partecipò solo il 5% degli aventi diritto al voto. In essa, tra l’altro, si sanciva la trasformazione delle concessioni di terre date in precedenza ad aziende straniere in loro proprietà a pieno titolo.
Gli atteggiamenti razzistici degli invasori statunitensi, le loro pretese di costruire infrastrutture stradali e portuali ricorrendo al sistema gratuito delle corvée, le loro politiche a favore di una modernizzazione (istruzione pubblica, servizio sanitario, sistema telefonico) che andava, però, esclusivamente a vantaggio degli occupanti e delle locali élite filostatunitensi, esacerbarono il risentimento della popolazione haitiana, tanto che alla fine del 1918 il Paese caraibico sprofondò in uno stato insurrezionale.
Mentre diversi intellettuali, generalmente di origine mulatta e francofoni (tra cui Jacques Roumain, uno dei fondatori nel 1934 del Partito Comunista Haitiano), manifestavano attraverso la letteratura e l’arte la loro opposizione all’arroganza straniera, si costituì nel paese un movimento armato di circa 40000 contadini – i cosiddetti “Cacos” – che arrivò, nell’ottobre del 1919, ad attaccare la capitale Port-au-Prince. Ci vollero due anni prima che i soldati statunitensi riuscissero a sedare la ribellione e la repressione dei marines fu talmente brutale che lo stesso Congresso USA decise di istituire una commissione d’inchiesta che indagasse sulle violenze commesse dai suoi militari.
Il risultato dell’indagine fu l’elezione nel 1922 di un nuovo presidente, Louis Borno, ancora più fedele del precedente agli interessi statunitensi.
Gli Stati Uniti assunsero il controllo totale – mantenuto fino al 1946 – della politica doganale haitiana; parificarono, con gravi conseguenze sulla vita dei ceti più poveri, la moneta locale al dollaro; trasportarono le riserve auree e monetarie del Paese a New York, presso la National City Bank, rifiutandosi poi quest’ultima di pagare i dovuti interessi ad Haiti (con un danno per lo Stato haitiano stimato intorno al milione di dollari). Furono potenziate le forze di polizia e venne ricostituito l’esercito al fine di reprimere eventuali ribellioni popolari.
Ed è ciò che effettivamente accadde nel 1929, quando, a seguito del crollo della Borsa di Wall Street e della contrazione delle esportazioni agricole, il governo fantoccio haitiano impose, al fine di rifarsi dei profitti perduti, nuove e pesanti imposte ai contadini dell’isola, che nel dicembre di quell’anno ripresero le armi.
Nella primavera del 1930 gli Stati Uniti cominciarono a preparare il loro ritiro da una sempre più ostile Haiti, non prima però di aver commesso nuove efferatezze nei confronti della popolazione contadina e di aver insediato alla guida della repubblica caraibica altri presidenti a loro “devoti”. Gli USA lasciarono infine Haiti nell’agosto del 1934.
La dittatura dei Duvalier: “Papà Doc” e “Baby Doc”
Con la ritirata statunitense, l’esercito haitiano tornò ad essere protagonista indiscusso della vita politica del Paese. Fino al 1957 vari presidenti si succedettero alla guida dell’isola, regolarmente deposti da golpe militari organizzati dalle diverse e rivali fazioni che si agitavano all’interno delle forze armate. Senza che mai, comunque, fosse messa in dubbio da alcuno la dipendenza politica ed economica del Paese dagli Stati Uniti d’America.
Ma nel settembre del 1957, con l’affermazione alle elezioni presidenziali, sali al potere il medico Francois Duvalier, detto “Papà Doc”. Egli poté contare, grazie a promesse demagogiche e credenze popolari, sull’appoggio della maggioranza della popolazione nera.
Papà Doc impose da subito una politica di tipo dittatoriale: sciolse i partiti d’opposizione, epurò gli ufficiali inaffidabili dell’esercito, esautorò – fino a decretarne lo scioglimento – il Parlamento, governò esclusivamente tramite decreti presidenziali.
Il dittatore disponeva di una milizia paramilitare – i Volontari per la Sicurezza Nazionale, tristemente conosciuti come i “Tonton Macoutes” – con la quale seminava il terrore e la morte in tutto il paese e nelle stesse forze armate (solo nel 1967 si contano almeno 2000 esecuzioni capitali, tra cui molte quelle che riguardarono i militari).
Il 1° aprile 1964 Francois Duvalier si proclamò “presidente a vita” della Repubblica di Haiti, godendo del sostegno incondizionato degli USA -ai quali si presentava come l’unico baluardo contro la diffusione del comunismo nell’area caraibica, soprattutto dopo il trionfo della rivoluzione a Cuba – e del ritrovato appoggio della Chiesa cattolica – dopo alcuni anni di raffreddamento nelle loro relazioni a seguito della persecuzione di alcuni rappresentanti del clero haitiano.
Nel febbraio 1971, a poche settimane dalla morte (aprile di quell’anno), Papà Doc organizzò un plebiscito popolare con cui “ottenne” la designazione del figlio, il diciannovenne Jean-Claude Duvalier (poi detto “Baby Doc”), quale suo successore.
Nonostante il dilagare della corruzione, dell’incompetenza, del malcontento della popolazione nera (diversamente dal padre, il giovane Duvalier cercò l’appoggio della componente mulatta della società haitiana) e le nuove tensioni con le gerarchie cattoliche romane, Baby Doc riuscì a governare il Paese per altri 15 anni, fino al gennaio 1986, quando una sollevazione popolare lo costrinse all’esilio in Francia.
La fine della quasi trentennale dittatura della famiglia Duvalier non significò però per il popolo haitiano l’inizio di una storia di libertà, di democrazia, di giustizia sociale.
La parabola di Jean-Bertrand Aristide. L’illusione di un cambiamento
Dopo la fuga di Jean-Claude Duvalier, l’esercito – insieme, questa volta, con i Tonton Macoutes – represse nel sangue le manifestazioni popolari che avevano portato alla caduta di Baby Doc, mentre, tra i vari leader della sollevazione, emerse la figura di un ex prete salesiano ed esponente della Teologia della Liberazione, Jean Bertrand Aristide.
E quando, solo nel dicembre 1990, si poterono tenere nuove e partecipate elezioni presidenziali la vittoria, con il 67% dei voti, arrise proprio ad Aristide, che si presentò promettendo più democrazia ed una maggiore giustizia sociale ed uguaglianza razziale.
Ma le speranze di una rinascita per il popolo haitiano cozzarono, solo nove mesi dopo, con il golpe militare, sostenuto dal presidente USA Bush e dalla Cia, del generale Cedras. Paradossalmente Aristide ed altri suoi sostenitori ripararono proprio negli Stati Uniti, protetti da ambienti del partito democratico ostili all’amministrazione repubblicana. (E ciò mentre l’OSA e l’ONU imponevano al nuovo regime pesanti sanzioni economiche che finirono solo per aggravare le già dure condizioni di vita della popolazione mentre le élite politiche e militari del Paese si sostenevano favorendo il traffico internazionale di droga attraverso i porti haitiani). Sotto la protezione del nuovo presidente degli USA, il democratico Bill Clinton, Aristide fece ritorno ad Haiti nell’ottobre 1994 per essere reintegrato nelle sue funzioni di presidente fino al 1996, quando gli fu negata dalla vigente Costituzione la possibilità di esercitare un secondo mandato presidenziale (e ciò nonostante che potesse contare ancora sull’appoggio di gran parte della popolazione povera haitiana).
In un contesto segnato da una crescente violenza politica e criminale, Aristide, a capo di un nuovo movimento nazional-populista, venne di nuovo rieletto presidente di Haiti nelle elezioni del 2000 (ma, in questa occasione, con un’affluenza complessiva alle urne di appena il 50% degli elettori).
La sua storia politica si interruppe definitivamente nel 2004, quando, abbandonato dagli Stati Uniti e da buona parte dei suoi stessi sostenitori, un nuovo colpo di stato lo costrinse a lasciare la carica presidenziale e ad imboccare la via dell’esilio (questa volta in Sudafrica).
Ma la parabola discendente del “prete dei poveri” era in realtà iniziata quando, nell’autunno del ’94, egli aveva rimesso piede nel palazzo presidenziale di Port-au-Prince scortato dai marines statunitensi.
La tutela yankee su Aristide significò per la popolazione haitiana la fine di ogni speranza riformistica e progressista. La “riconoscenza” verso gli USA e la necessità di non perdere gli aiuti finanziari promessi da alcuni istituti internazionali – in primis il FMI – costrinsero Aristide ad accettare molti compromessi: dalla privatizzazione – a vantaggio soprattutto di aziende nordamericane e francesi – di svariate imprese statali alla riorganizzazione della polizia e dell’esercito sotto la supervisione di addestratori statunitensi, fino all’esproprio di altre terre e all’imposizione di nuove imposte a danno delle comunità contadine e delle classi medie; non ultimo il blocco forzato dell’emigrazione haitiana verso la Florida.
Aristide cercò poi di rientrare in patria nel 2011 ma, completamente isolato ed anzi sottoposto ad accuse di malversazione e di altri crimini, riprese la via dell’esilio.
Gli ultimi venti anni di Haiti
Dunque Haiti non è nuova dall’accogliere sul suo territorio una presenza militare straniera.
A seguito del ricordato golpe militare del 1991, l’isola caraibica aveva già “ospitato” tra il 1993 ed il 2001 diversi interventi ONU, aventi come obbiettivo la “stabilizzazione democratica” del Paese e l’addestramento di nuove forze di polizia. Quindi gli haitiani si guadagnarono nuovamente l’attenzione della “Comunità Internazionale” all’indomani della ribellione armata che costrinse nel 2004 il presidente Aristide alla fuga in Sudafrica. A quel punto le Nazioni Unite decisero – soprattutto per volontà degli USA – di colmare il conseguente vuoto di potere inviando una consistente missione, sotto bandiera ONU ed affidata al comando di ufficiali brasiliani, composta da militari provenienti da più di 35 paesi. Questa spedizione (denominata Minustah) rimase nel Paese fino al 2017, attirandosi l’odio di gran parte della popolazione locale a causa dei gravissimi abusi, soprattutto sessuali, commessi nei confronti di minori e di tante giovani donne haitiane.
Poi nel 2010, con il devastante terremoto che sconvolse la parte haitiana dell’isola Hispaniola – circa 300.000 i morti – vi fu una ulteriore spedizione Onu, questa volta sotto comando USA, che agli occhi degli haitiani parve più che un intervento a fini umanitari una vera e propria occupazione militare delle aree strategiche (la capitale, i porti, le miniere di rame, bauxite, nichel, oro ed argento) dello stato caraibico. Inoltre la nuova missione ONU fu ritenuta responsabile dalla già martoriata popolazione haitiana dell’esplosione di una drammatica epidemia di colera che provocò nel tempo la morte di almeno altre 10.000 persone e durante la quale si distinsero per la loro abnegazione i medici inviati da Cuba.
Solo nel 2016, dopoché l’ONU considerò ristabilite le condizioni di legalità necessarie per la ripresa di una vita “democratica” ad Haiti, furono indette nuove elezioni presidenziali, vinte dal giovane imprenditore Jovenel Moise.
Il neo presidente operò scelte sia di politica interna che internazionale caratterizzate da ambiguità ed oscillazioni: dagli appelli a difesa della sovranità nazionale (evocando le lotte anticoloniali ed antischiaviste sostenute dagli haitiani alla fine del ‘700) al dover fare i conti con le pressioni esercitate dall’“invadente” vicino statunitense (da qui il conseguente raffreddamento nel luglio 2018 delle relazioni diplomatiche e commerciali con il Venezuela bolivariano); da riforme economiche di stampo populista in contrasto con i dettami del FMI ai condizionamenti imposti sul piano economico e sociale dai più forti clan familiari presenti nell’isola.
Una controversa gestione della pandemia da Covid 19 ed un crescente accentramento del potere nelle mani del presidente – a scapito dei già ristretti margini di agibilità politica a disposizione dei gruppi di opposizione – generarono proteste popolari, ripetuti ed inutili rimpasti governativi, tentativi di colpi di Stato.
Jovenel Moise è stato infine assassinato, in circostanze mai perfettamente chiarite, nel luglio 2021, quando un commando di sicari, al soldo, sembra, di trafficanti di droga colombiani, assaltò con successo la residenza presidenziale. Jovenel Moise avrebbe così pagato con la vita – secondo quanto affermato dai suoi seguaci – la sua volontà di colpire le vie del narcotraffico tra la Colombia ed Haiti.
Il Primo Ministro Claude Joseph decretò lo stato d’assedio nell’intero territorio nazionale, assumendo di fatto il controllo dei mezzi di comunicazione ed isolando quindi il Paese dal resto del continente americano e del mondo intero.
Solo pochi giorni dopo lo stesso Joseph venne rimpiazzato alla carica di Primo Ministro da Ariel Henry, considerato uno dei possibili mandanti dell’assassinio di Moise ed un fantoccio dell’amministrazione USA. Ma il fedelissimo di Washington, ancora oggi al potere, si è dimostrato incapace di preservare il Paese dal caos e di garantire il “tranquillo” sfruttamento delle sue ricchezze da parte del potente protettore. Sono le gang criminali – ed alcune in particolare, equiparabili a piccoli eserciti – a dettare legge nel Paese e soprattutto nella capitale Port au Prince.
Le bande criminali
Formate e in molti casi guidate da ex poliziotti ed ex militari, le bande criminali, presenti in tutto il Paese ma soprattutto nella capitale (se ne contano più di 100), hanno assunto oramai il controllo di due terzi dell’isola e di circa l’80% di Port au Prince. Dediti a molteplici attività criminose – dal traffico di droga in combutta con i cartelli colombiani e con i cui proventi le gang si riforniscono di armi, ai sequestri di persona con richiesta di riscatto fino ad assassinii su commissione e a violenze di ogni genere e contro chiunque indistintamente – questi gruppi si sono resi protagonisti di azioni degne di veri e propri piccoli eserciti. La famigerata “G9 an fanmi ak alye” (“G9 nella famiglia e negli alleati”), capeggiata dall’ex poliziotto Jimmy Chérizier (conosciuto come “Barbecue”), blocca militarmente il terminal petrolifero di Varreux, collocato nel porto della capitale haitiana e sito dove viene immagazzinato gran parte del carburante destinato allo svolgimento delle attività quotidiane e produttive nell’isola caraibica. È quindi la “G9” che provvede a far uscire il carburante dal terminal, riversandolo sul “mercato nero” a prezzi stratosferici. Un’altra banda – la “5 Seconds” – ha assaltato nel giugno 2022 il Palazzo di Giustizia di Port au Prince, cacciando i funzionari governativi, saccheggiando e devastando l’edificio, mandando completamente in tilt l’intero apparato giudiziario del Paese.
Nella totale impossibilità per i 14.000 poliziotti – un numero di molto inferiore a quello di coloro che fanno parte della criminalità organizzata in bande – che dovrebbero garantire l’ordine pubblico e la sicurezza ad Haiti, di contrastare lo strapotere di queste organizzazioni, si contano nell’isola caraibica tra il gennaio ed il settembre 2023 almeno 3000 omicidi, quasi 1500 sequestri di persona, circa 200.000 persone costrette ad abbandonare le proprie case per sfuggire alla violenza criminale, un numero elevatissimo di stupri – usati come strumento di punizione e di intimidazione.
Nel Paese considerato come uno dei più pericolosi al mondo per l’incolumità fisica delle persone, non va certamente meglio a giornalisti e reporter. Molti sono coloro che sono stati rapiti, torturati, uccisi, soprattutto quando impegnati ad indagare sui rapporti che legano queste bande criminali a quei gruppi paramilitari – eredi dei Tonton Macoutes – che ricorrono anch’essi a violenze ed efferatezze contro attivisti sindacali e dei diritti umani per conto delle élite politiche ed economiche dominanti nell’isola.
Le condizioni della popolazione haitiana
La parte haitiana dell’isola Hispaniola – divisa ad oriente con la Repubblica Domenicana- è abitata da circa 11 milioni di persone, di cui circa 3 milioni concentrate nell’area metropolitana della capitale Port au Prince – alle cui porte sorge la baraccopoli di Cité Soleil (400.000 abitanti), teatro nel 2007 di una vera e propria guerra, durata diverse settimane, tra le gang criminali da un lato e le forze Onu e di polizia locale dall’altro.
Haiti è oggi uno dei cinque paesi più poveri al mondo, con un’inflazione che si attesta attorno ad un +33% annuo, con una popolazione stremata ed affamata che, dopo la decisione presa – su “consiglio” del FMI – dal governo di Ariel Henry di eliminare i sussidi governativi per l’acquisto di carburanti e di viveri, si è resa protagonista di disordini e saccheggi in varie zone del Paese. E ciò mentre per molte famiglie haitiane l’unica speranza di sopravvivenza quotidiana è quella di sacrificare minori e giovani donne ai potenti racket della prostituzione. Inoltre i sempre più frequenti black out elettrici che causano la paralisi delle attività produttive e commerciali, si sommano alla carenza di benzina – la cui distribuzione è oramai prerogativa dei gruppi criminali che ne controllano lo stoccaggio – determinando il blocco dei trasporti e con esso il collasso della già precaria struttura sanitaria: ambulanze ferme, ritardi nella consegna dei medicinali agli ospedali, mancato ritiro dei rifiuti – tanto che si sta riaffacciando nel paese lo spettro del colera. E se questa è la drammatica condizione in cui versa la popolazione urbana, nelle zone rurali e periferiche dell’isola la situazione appare ancor più grave, venendo meno in particolare una regolare fornitura di acqua potabile che alimenta il rischio di insorgenza di altre malattie epidemiche.
La nuova missione internazionale
È in questo contesto di instabilità politico-istituzionale, di paura ed insicurezza, di tensioni sociali, di estrema povertà, che è maturata la volontà del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di inviare ad Haiti una forza armata multinazionale (la MSS, Multinational Security Support) “affinché gli haitiani possano tornare a fare una vita normale” secondo quanto affermato dal portavoce dell’ONU Farhan Haq.
La risoluzione, sollecitata in particolare – come già detto – dagli USA e dal Canada (“impressionati” dalle violenze subite da alcuni cittadini nordamericani residenti nell’isola caraibica), prevede che dal gennaio 2024 un contingente internazionale composto da reparti speciali di polizia e da altre unità di supporto militare venga impiegato sul territorio haitiano in aiuto alla polizia locale e a protezione di porti, aeroporti, siti produttivi e commerciali, scuole, ospedali e di altri luoghi “sensibili” tenuti sotto scacco dalla violenza delle bande criminali.
La missione, che non agirà sotto bandiera ONU e non conterà nelle sue fila agenti di polizia o militari statunitensi e canadesi, avrà intanto la durata di un anno – con una prima valutazione degli effetti dell’intervento dopo nove mesi. Il comando del contingente sarà affidato ad ufficiali kenyani, dopoché il paese africano -tra non poche titubanze e polemiche – ha accettato tale incarico, promettendo anche di mettere a disposizione ben 1000 uomini delle sue forze speciali di polizia.
Alla presenza del Kenya si è poi aggiunta quella di altri paesi: Bahamas, Giamaica, Antigua, Barbuda e probabilmente il Perù. Ancora da definire nei particolari la partecipazione di Mongolia, Senegal, Belize, Suriname, Guatemala. Anche la Spagna e l’Italia hanno dichiarato il loro interesse a far parte della missione. (L’Italia aveva peraltro già partecipato, tra il 2008 ed il 2010, con 120 uomini dei reparti speciali dei carabinieri, alla missione ONU Minustah). Stati Uniti e Canada “si limiteranno” invece a fornire all’intervento internazionale un apporto logistico e finanziario (con uno stanziamento di 100 milioni di dollari).
Ai partecipanti alla missione saranno assegnati poteri molto ampi. Oltre ad addestrare ed affiancare nelle operazioni di polizia gli agenti haitiani, essi potranno adottare misure di emergenza, procedere a perquisizioni, fermi ed arresti, ricorrere all’uso della forza ogni qualvolta necessaria per ripristinare l’ordine pubblico e “liberare” dalla presenza della criminalità organizzata le zone nevralgiche – come l’area portuale – della capitale Port au Prince.
L’obbiettivo finale, si afferma, è quello di creare le condizioni adatte per uno svolgimento “democratico” delle prossime elezioni che ad Haiti non si tengono dal 2016.
La MSS e le critiche ad Haiti…
Al di là dello scontato plauso alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza da parte del Segretario Generale dell’Onu, il portoghese Antonio Guterres, del direttore generale dell’OMS, del governo haitiano di Ariel Henry e dei suoi “protettori” internazionali (in primis gli USA), la nuova missione MSS ha suscitato forti critiche e perplessità all’interno di Haiti.
Infatti l’intervento di stati stranieri non sembra risultare molto gradito a buona parte degli haitiani. Numerose organizzazioni popolari e circoli di attivisti dei diritti umani, di tutela dei minori, di contrasto alla corruzione, hanno dichiarato la loro intenzione di promuovere un vero e proprio “assedio” delle istituzioni pubbliche haitiane e di diverse ambasciate (in particolare quelle di USA, Canada e Francia) al fine di dimostrare la loro ostilità verso la presenza di forze straniere sul territorio haitiano e di ottenere le dimissioni di Ariel Henry e la formazione di un governo di transizione composto da rappresentati di tutti i partiti e della società civile che traghetti autonomamente il paese verso nuove elezioni.
Diverse poi sono le associazioni umanitarie e le comunità religiose di base – eredi della Teologia della Liberazione – che hanno espresso forti timori in merito all’affidamento della guida della missione al Kenya. Le forze speciali di quel paese, infatti, sono state protagoniste di efferate violenze (stupri, torture, uccisioni a sangue freddo) e di gravi violazioni dei diritti umani in occasione di altre – in particolare nel Corno d’Africa – missioni di “pace” o di interposizione tra paesi belligeranti.
Al fine di placare le proteste l’ONU ha previsto l’applicazione di “misure” atte a prevenire – o a punire con fermezza – eventuali abusi sessuali od altre manifestazioni di “cattiva condotta” da parte dei militari stranieri e a garantire una più facile comunicazione tra gli ufficiali africani che parlano inglese e swahili e gli haitiani di lingua francese e creola. Ma l’adozione di questo “codice comportamentale” non ha comunque abbassato il livello di preoccupazione della popolazione locale.
Ma le reazioni più decise all’ingresso di poliziotti e militari stranieri ad Haiti sono state manifestate proprio dai più influenti capi delle varie gang criminali. Il già ricordato “Barbecue” ha lanciato una vera e propria “chiamata alle armi”, promettendo guerra aperta per rovesciare il governo attuale e contrastare in armi la forza multinazionale quando questa metterà piede sull’isola. Sembra in tal modo profilarsi un drammatico scenario di guerra urbana che finirebbe per sprofondare definitivamente nel baratro la già tormentata popolazione haitiana.
… e sul piano internazionale
Ha destato sorpresa l’astensione, in sede di Consiglio di Sicurezza ONU, di Russia e Cina, da cui ci si attendeva, se non il ricorso al veto, almeno un voto contrario, considerando che nessuno ha potuto dubitare del preponderante ruolo svolto dagli USA nel sostenere questo intervento internazionale. Probabilmente non si è voluto innalzare da parte dei due paesi il livello di scontro geopolitico in atto da tempo tra i 15 membri del Consiglio (si pensi soltanto alle tensioni generate dal conflitto russo-ucraino o dalla questione di Taiwan, aggravate poi, nei giorni seguenti la votazione, dalle drammatiche vicende mediorientali).
In particolare il rappresentante cinese alle Nazioni Unite, Zhang Jun, non ha esitato ad esprimere critiche molto severe verso la nuova missione multinazionale, inviata a sostegno di un governo – quello di Ariel Henry – giudicato dalla Cina privo di legittimità popolare e complice del traffico di armi che dagli Stati Uniti, con l’appoggio della diaspora haitiana in Florida, sbarcano nell’isola caraibica.
Forti proteste verso la decisione presa dal Presidente del Kenya, William Ruto, di assecondare la proposta USA di guidare questa difficile spedizione oltreoceano si sono avute proprio nel paese africano. Gli oppositori di Ruto e buona parte della stampa kenyana si domandano quali siano le motivazioni per cui il paese – alle prese, tra l’altro, con una grave crisi economica e finanziaria che sta pesantemente aggravando le condizioni di vita della popolazione – si debba imbarcare in una missione giudicata molto impegnativa e rischiosa. Alcuni politici e giudici locali hanno anche denunciato come illegale questa scelta la quale, non avendo avuto ancora alcuna approvazione da parte del Parlamento di Nairobi, pone questioni di incostituzionalità circa il mandato affidato allo stato africano.
Le ragioni di questa presa di posizione della dirigenza kenyana sono da ricercare senz’altro nell’accordo di cooperazione politico-militare sancito ufficialmente il 25 settembre 2023 tra gli Stati Uniti ed il Kenya. Si tratta di un’intesa – della durata, al momento, di cinque anni e dal costo per gli Usa di 100 milioni di dollari – che prevede tra l’altro la dotazione di equipaggiamenti e di armamenti più moderni per l’esercito kenyano e l’addestramento di truppe d’élite da parte di istruttori statunitensi. La giustificazione che sta alla base di questo accordo – al di là della preparazione di cui le forze keniane dovrebbero disporre per dirigere la MSS ad Haiti – risiede nella comune volontà dei due stati di contrastare più efficacemente il pericolo di infiltrazione di cellule terroristiche islamiche nel territorio del paese dell’Africa orientale.
Molti analisti ed esperti di politica internazionale ritengono invece che questa stretta cooperazione sia finalizzata al contenimento di quell’ondata di protesta anti-occidentale che sta attraversando molte nazioni africane. Un forte fremito di ribellione che ha portato all’instaurazione, sia pure spesso attraverso golpe militari, di regimi decisamente ostili soprattutto alla Francia e agli stessi USA e viceversa assai benevoli verso la Russia. È il caso del Mali, del Niger, del Burkina Faso mentre sono al momento falliti tentativi simili in Sierra Leone e nel Gabon ed estese manifestazioni di protesta sono state duramente represse in Senegal.
Quindi il Kenya, legato a doppio filo alla politica imperialista degli USA e strozzato da un debito estero cresciuto a dismisura con la presidenza di William Ruto, è stato “chiamato” a fare nella lontana Haiti il “lavoro sporco” – consistente innanzitutto nel ristabilire il pieno controllo sullo sfruttamento delle risorse alimentari e minerarie dell’isola caraibica – per conto di Stati Uniti e Francia.
… e in America Latina?
Nell’area centro-sud americana – quella parte di continente che è considerata dagli USA come il proprio “cortile di casa” – il disegno imperialista che soggiace al nuovo intervento armato ad Haiti è stato apertamente denunciato da Cuba.
Il governo dell’Avana si è schierato contro l’invio di una missione militare nell’isola ed il paventato uso della “forza”, sostenendo, al contrario, che Haiti necessita semmai di una assistenza umanitaria e di forme di cooperazione economica incentrate sul rispetto della sovranità dell’isola e della dignità della sua popolazione. Il Ministero degli Esteri cubano ha ricordato come il saccheggio coloniale e neocoloniale – concretatosi ora attraverso una costante sudditanza economica agli USA, ora tramite interventi militari esterni – sia all’origine della povertà, del sottosviluppo, dell’instabilità sociale e della mancanza di sicurezza nella vicina isola caraibica.
In un contesto mondiale caratterizzato dall’esplosione di sanguinosi conflitti, dall’acutizzarsi della tensione su scala internazionale, dal manifestarsi di nuovi focolai di guerra, nel giudizio espresso dal governo cubano circa la decisione di procedere di fatto ad una nuova “occupazione” militare di Haiti, non è sfuggita la considerazione che questa mossa, anche facendo salve le buone intenzioni di una parte dell’ONU di prestare aiuto alla popolazione haitiana, non possa infine tradursi in un tentativo di destabilizzazione dell’area centrale e caraibica del continente americano che avrebbe ovviamente nella Cuba socialista il suo primo e principale obbiettivo.
La valutazione fatta dai cubani non ha trovato però particolare sostegno in altri paesi dell’area. A parte il Nicaragua, la Bolivia, in parte il Venezuela, gran parte degli Stati latino americani hanno concordato con la risoluzione ONU del 2 ottobre ed alcuni in particolare hanno anche offerto – come si è visto – la propria disponibilità a far parte della nuova missione internazionale.
Questa frattura nell’area latino-americana sul giudizio da dare alla missione MSS ha costituito, in certo qual modo, una sorta di premessa per il successivo e diverso posizionamento assunto dai vari stati centro-sud americani rispetto alle drammatiche vicende della guerra israelo-palestinese.
I comunisti haitiani
Purtroppo il movimento comunista haitiano non ha la forza, innanzitutto per la sua esiguità, di organizzare e di mobilitare le masse popolari e proletarie del Paese contro i nuovi propositi imperialisti di occupazione dell’isola.
Il New Haitian Communist Party (NHCP), di tendenza maoista, fondato da poche centinaia di attivisti marxisti-leninisti nel 2000, risente ancora delle conseguenze negative dovute alla dissoluzione del Puch (United Party of Haitian Communists) tra il 1989 ed il 1991, quando la dirigenza del partito, a seguito degli eventi verificatisi nella lontana Europa orientale, decretò la fine dell’esperienza comunista, lo scioglimento dell’organizzazione e la confluenza dei suoi militanti in un più ampio Fronte di Resistenza Nazionale.
Le origini del movimento comunista ad Haiti risalgono al 1934, quando venne costituito da un piccolo gruppo di intellettuali, soprattutto storici e scrittori (tra cui la figura più prestigiosa era senz’altro quella del già ricordato Jacques Roumain), il Partito Comunista Haitiano. Il movimento si distinse da subito per la sua opposizione all’occupazione statunitense, per i suoi richiami al sentimento nazionale haitiano e alle lotte antischiaviste di fine ‘700, ma anche per la riscoperta dei valori comunitari e solidaristici delle originarie popolazioni indigene. Nonostante i contatti stabilitisi tra il HCP e i “Cacos”, l’alleanza tra questi esponenti – spesso anche molto apprezzati fuori dei confini nazionali – della cultura francofona in Haiti ed il movimento contadino ribelle – dove, tra l’altro, era dominante la lingua creola – non ebbe successo.
Nel 1936 il giovane partito comunista venne posto fuorilegge e molti dei suoi dirigenti e militanti furono uccisi, incarcerati o costretti all’esilio.
Da quel momento il movimento comunista haitiano, alle prese con una incessante e spietata repressione governativa – che raggiungerà il suo culmine con la dittatura dei Duvalier – sarà obbligato a riorganizzarsi continuamente, assumendo denominazioni diverse o “mascherandosi” all’interno di più generici fronti nazionali o popolari. (Come Partito Socialista Popolare Haitiano, i comunisti riusciranno addirittura a far eleggere due deputati nelle elezioni politiche del 1946. Ma nel 1949 anche questo partito fu posto al bando).
Anche il movimento comunista haitiano è andato incontro nel corso delle sue vicissitudini ora a fusioni ora a successive scissioni tra le sue componenti.
D’altronde in un paese la cui storia è stata profondamente segnata dall’esperienza coloniale e neocoloniale, dal regime schiavistico e dagli odi razziali, la “natura” che era venuta assumendo nel tempo la società haitiana e, di conseguenza, la strada da percorrere per trasformarla in senso socialista, non potevano non costituire, a seconda dell’analisi che se ne faceva, motivo di discussione e di scontro tra i comunisti dell’isola caraibica.
Affermando il carattere semifeudale e semicoloniale della società haitiana, una parte del locale movimento comunista ha sostenuto negli anni la necessità di una rivoluzione nazionale, democratica, antimperialista, come prima ed inevitabile fase verso la costruzione del socialismo, passando quindi anche attraverso esperienze frontiste con altre forze politiche e sociali non necessariamente riconducibili al marxismo-leninismo.
Altre aree invece, pur ammettendo l’esistenza di consistenti sacche di arretratezza culturale e socio-economica nella popolazione haitiana, hanno evidenziato, oltre alla forte propensione alla lotta manifestata da questo popolo in molti passaggi della sua storia e all’essere sempre stato di fatto inserito nelle dinamiche geopolitiche ed economiche mondiali (ancor più oggi con i processi di “modernizzazione” capitalistica e di globalizzazione economico-finanziaria in atto), il progressivo rafforzarsi di un proletariato industriale (dagli operai delle industrie alimentari ed estrattive ai quadri tecnici delle aziende multinazionali dell’elettronica fino ai portuali) molto combattivo sul piano delle rivendicazioni economiche ma debole dal punto di vista delle prospettive politiche, in quanto privo di adeguati ed autonomi strumenti politico-organizzativi. Da qui la necessità di ricostruire, nonostante le difficoltà, un partito indipendente – estraneo ad ipotesi frontiste – dei lavoratori haitiani, quale loro punto di riferimento nella lotta per l’immediata instaurazione della dittatura del proletariato e per l’edificazione del socialismo.
Concludendo
“È una situazione assolutamente da incubo per la popolazione di Haiti. Nelle circostanze attuali è indispensabile un intervento armato”, ha affermato il segretario dell’ONU Guterres; “Il popolo di Haiti non sta vivendo, sta sopravvivendo”, ha incalzato Jean Victor Geneus, ministro degli Esteri haitiano; “La decisione dell’ONU è un raggio di speranza per il Paese”, ha rilanciato il primo ministro Ariel Henry. E così via con altri commenti (dal segretario di Stato USA Blinken al direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus) ispirati a drammaticità e fiducia verso l’azione che potrà dispiegare in terra haitiana la missione internazionale MSS.
Indubbiamente se è vero che la popolazione haitiana nel suo complesso e le sue componenti più deboli in particolare non possono non soffrire pesantemente per il clima di paura e di insicurezza creato nel paese dalle bande criminali, non si può dimenticare che queste stesse gang sono state in origine finanziate dai ricchi imprenditori haitiani per colpire – in appoggio ai già ricordati gruppi paramilitari – chi si opponeva – sindacalisti, attivisti dei diritti umani, avvocati, giornalisti – al loro dominio di classe ed utilizzate dalle élite politiche locali per condizionare le scelte sia di politica interna che internazionale del Paese. Oggi, nel vuoto di potere che si è di fatto aperto dopo l’assassinio di Jovenel Moise, queste organizzazioni criminali agiscono autonomamente, scagliandosi anche contro i loro vecchi padroni.
E in un paese dove l’80% della popolazione vive in uno stato di povertà giudicata “degradante” per la dignità dell’essere umano, mentre l’1% controlla pressoché la totalità della ricchezza nazionale e quasi tutte le attività industriali e minerarie sono in mano a grandi aziende straniere – in primis statunitensi – non ci si può stupire come molti adolescenti ed emarginati trovino l’unica forma di ribellione e di sopravvivenza o “arruolandosi” nei ranghi della criminalità organizzata o cercando di fuggire nella vicina Repubblica Domenicana (che sempre più frequentemente chiude i propri confini, schierando anche l’esercito, all’ingresso degli haitiani).
Oggi la “Comunità Internazionale” sbandiera la causa dei poveri di Haiti – “buco nero del mondo”, come l’ha definita l’ambasciatore Usa a Port au Prince – schiacciati in realtà tra la efferatezza delle bande criminali e lo sfruttamento – vera causa della povertà e della violenza – cui è sottoposta la popolazione di quel paese dai padroni interni ed internazionali.
L’intervento armato che si va predisponendo si presenta pertanto sia come un puntello per l’illegittimo governo Henry, in quanto garante del mantenimento della condizione di asservimento dei lavoratori haitiani tanto della campagna quanto delle città, sia la trasformazione dell’isola caraibica in un potenziale avamposto militare al servizio degli interessi geopolitici dell’imperialismo statunitense nella prospettiva di una futura – se necessaria – destabilizzazione dell’area centro-caraibica.
A cura della Commissione Internazionale di Unione di Lotta per il Partito Comunista (ULPC)
Febbraio 2024
